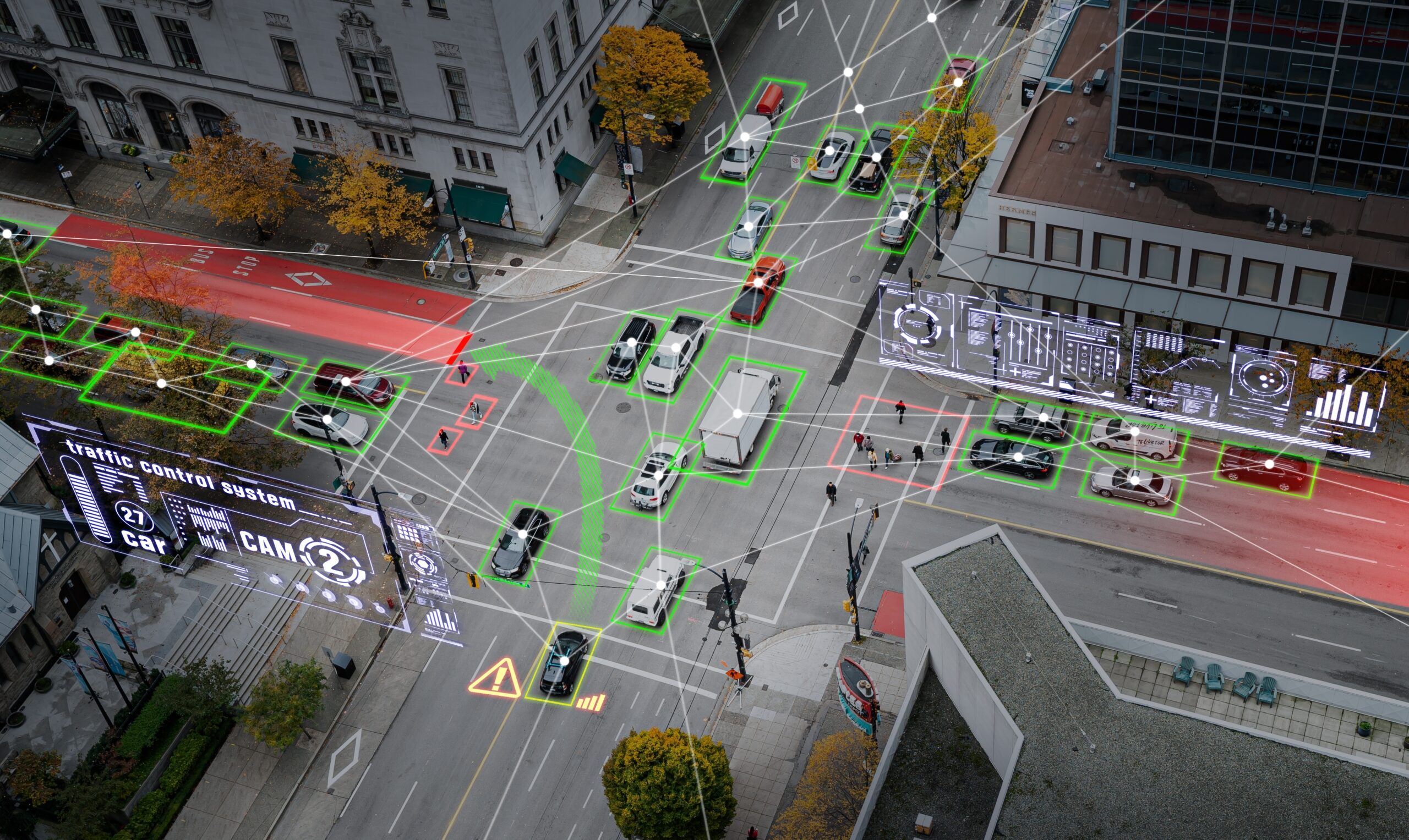“Le startup italiane non ce la possono fare se non vengono accompagnate nel loro percorso dalle grandi e medie industrie, come succede già da tempo negli Usa”. A dirlo è Riccardo Varaldo, economista industriale, già presidente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sostenitore con Giovanni Alberto Agnelli, a metà degli anni ’90, della realizzazione del Polo Tecnologico Sant’Anna in Pontedera, centro di rango internazionale nella robotica umanoide, e dal 2010 uno dei promotori, con Corrado Passera, della nascita della Fondazione Ricerca & Imprenditorialità. È un organismo di cui sono Fondatori quattro grandi imprese (Enel, Finmeccanica, Telecom Italia, Banca Intesa Sanpaolo) e tre istituzioni universitarie di eccellenza (Fondazione Politecnico di Milano, Istituto Italiano di Tecnologia e Scuola Superiore Sant’Anna), la cui missione è affiancare e sostenere la crescita di spin-off e startup tecnologiche. Varaldo è il presidente del consiglio di gestione, l’amministratore delegato e direttore generale di Finmeccanica, Mauro Moretti, presiede la Fondazione. Dal suo osservatorio Riccardo Varaldo è in grado di valutare lo stato dell’innovazione in Italia, argomento sul quale ha pubblicato di recente un libro, intitolato appunto “La nuova partita dell’innovazione” (Il Mulino). La valutazione non è purtroppo positiva. “Siamo molto indietro – dice – perché facciamo innovazione nello stile e nel design, ma per quanto concerne l’introduzione di nuove tecnologie e conoscenze tecnologiche restiamo arretrati. Un deficit che compromette la capacità di impresa. Se non riusciamo a recuperarlo, sarà difficile riuscire a riagganciare il treno della crescita”.
A cosa è dovuto questo deficit?
A seguito della grande crisi internazionale c’è stata un’accelerazione dell’innovazione tecnologica e della ricerca in molti Paesi che, in pratica, si sono dovuti attrezzare per migliorare la loro capacità di far fronte alla crisi. Avvenne così anche nel ‘29 e all’inizio degli anni Ottanta. Le grandi crisi scompaginano le carte del gioco, creano nuove esigenze, nuovi valori, nuovi visioni. In secondo luogo va rilevato che, negli ultimi dieci anni, c’è stato un processo di internazionalizzazione della ricerca. Prima la ricerca era la porta nobile dell’economia ed era sostanzialmente prodotta in Usa, Giappone e nella Ue. Con la globalizzazione gli investimenti in ricerca si sono moltiplicati in tanti altri Stati e continenti, e stanno andando avanti a un ritmo incredibile. In molti hanno capito che devono fare innovazione tecnologica, e non solo cercare di competere sui prezzi. D’altra parte le multinazionali hanno interesse a investire in economie in forte crescita come Cina ed India e questo traina la ricerca. Insomma, negli ultimi anni sono passati due treni: l’accelerazione dell’innovazione tecnologica e la globalizzazione.
L’Italia sta prendendo questi treni?
Si difende dal punto di vista della produzione di ricerche scientifiche: siamo tra i primi al mondo in questo campo. Ma a cosa serve se non sappiamo sfruttare le nostre capacità? La conoscenza scientifica è considerata un bene pubblico, il ricercatore non desidera altro se non pubblicizzare il più possibile le proprie ricerche, con Internet e i social network la diffusione del pensiero può aumentare in modo vertiginoso. Ma poi bisognerebbe saper tradurre il sapere in applicazioni pratiche. La verità è che, se in Italia non c’è un meccanismo di trasferimento e valorizzazione di queste conoscenze, noi siamo perdenti: stiamo regalando conoscenza scientifica al mondo, esportiamo conoscenza e importiamo prodotti provenienti da altri Paesi che sanno utilizzare le nostre scoperte per le loro industrie. Oltre che piangere per la fuga dei cervelli, si dovrebbe piangere per la fuga delle conoscenze.
Quindi il Made in Italy è un falso mito?
Abbiamo una creatività eccezionale: difficile trovare un altro Paese così ricco di immaginazione, inventiva, originalità. Ma non abbiamo grandi imprese in grado di sfruttare il processo creativo e farne un business a livello internazionale. L’Italia è una nazione purtroppo squilibrata tra la sua capacità di creazione del nuovo e la capacità di fare business, di fare industrializzazione della creatività.
Come cambiare rotta?
È un processo molto complesso e lungo. Innanzitutto bisogna andare a ricercare nel sistema imprenditoriale le imprese innovative, quelle che si distinguono dalle altre perché maggiormente in grado di fare innovazione. Bisogna facilitarne il compito e garantire incentivi.
Non è già stato fatto con la policy sulle startup innovative e con la recente introduzione della categoria delle pmi innovative?
È vero, si si sta cercando di cambiare ma con una pesante eredità alle spalle: politiche economiche deficitarie dal punto di vista degli incentivi all’innovazione. Dal lato industriale l’Italia è un Paese estremamente conservativo: tutte le regole fiscali, del lavoro ecc. ecc. hanno portato a una sorta di ingessatura del sistema. Anziché essere all’avanguardia sul fronte dell’innovazione, siamo all’avanguardia della conservazione. Per questo occorre sostenere startup e spin-off universitari.
Con quali strumenti?
Negli Usa la maggiore capacità di creazione posti di lavoro è attribuita alle pmi innovative, perché si ritiene che le vere innovazioni abbiamo difficoltà a essere portate avanti dalle grandi imprese, le quali non si possono permettere di correre rischi e devono far quadrare i conti. L’innovazione oggi richiede velocità di azione e prontezza di risposta. Negli Stati Uniti le grandi imprese riconoscono il valore delle startup e la loro maggiore capacità di risposta a certi stimoli, per cui le coltivano e le allevano . Finora in Italia questo si è visto poco. Invece è importante che le grandi e medie imprese italiane si mettano a fianco di startup e spin-off, è una garanzia di maggiore possibilità di successo. I grandi devono capire e aprire gli occhi. È quello che intendiamo fare con Fondazione Ricerca & Imprenditorialità: l’obiettivo è far sì che la grande impresa possa operare efficacemente a fianco di startup e spin-off provenienti da università, istituti di ricerca, ecc. ecc. per consentire loro di entrare sul mercato. Stiamo anche lanciando un progetto per accelerazione di startup a Genova.
Un modo per creare un collegamento più efficace tra ricerca e aziende?
Esatto. Ancora una volta gli Stati Uniti sono un esempio: negli ultimi anni le grandi aziende che avevano grandi laboratori di ricerca li hanno smantellati perché rappresentavano un impegno enorme in termini di risorse umane e finanziarie e tutto sommato si poteva trovare di meglio attraverso rapporti organici con le università. Stesso discorso per le startup: negli Usa se un big aiuta una startup e quella funziona, il secondo step è l’acquisizione. In Italia, invece, le exit sono rare e difficilissime. Insomma, c’è ancora molta strada da fare. Ma siamo in cammino.