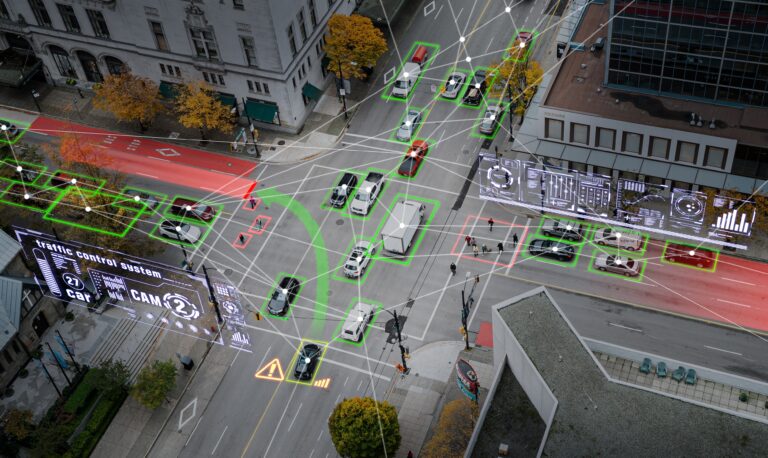Da diverse settimane imperversa un acceso dibattito sul film “The Startup” di Alessandro D’Alatri, che porta sullo schermo la storia (vera o presunta) di Egomnia, piattaforma di social network fondata nel 2012 da Matteo Achilli per abilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo dibattito va ben oltre la critica cinematografica, perché la deriva che può generare, se non prontamente arginata, potrebbe danneggiare l’intero ecosistema startup hi-tech italiano.
Mai avrei pensato di scrivere una sorta di recensione per un film, nonostante la mia malcelata cinefilia. Ma il rischio di cadere nella post-verità affidandosi alla storia narrata in questa pellicola è forte, e per scongiurarlo si richiede un intervento e una presa di posizione da tutte le prospettive possibili. Mettiamo subito in chiaro una cosa: questo film ha fatto arrabbiare molti addetti ai lavori. Sia chi le startup le vive dall’interno, creandole e finanziandole, con ambizione bilanciata da realismo; sia chi le studia e le supporta dall’esterno, con sobrietà e professionalità. Ma perché tutto questo livore? Si tratta solo dell’ennesimo esempio di invidia all’italiana, dove chi non fa commenta – e tipicamente critica? Oppure queste invettive – arrivate peraltro dallo stesso mondo che il film avrebbe dovuto celebrare – sono fondate? Provo a spiegarlo, non entrando nel merito del film (già stroncato da buona parte della critica), ma dei messaggi che più o meno implicitamente veicola.
Innanzitutto, “The Startup” non è una storia di successo. Egomnia avrà potuto mostrare del potenziale 5 anni fa alla sua nascita, ma nel tempo non ha mai dimostrato i numeri necessari per poter essere un caso degno di nota (una cosiddetta “scale-up”): round di finanziamento principalmente da FFF (“friends, family and fools”) e una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo miseramente fallita (target 100.000 $, raccolti 10 $…); fatturato e utili estremamente ridotti; costi del personale (e di conseguenza dipendenti) insignificanti; e soprattutto, pochissima “traction”, ossia bassissima presa sui clienti e effettiva capacità di generare traffico e crescita.
Nel contempo, non è nemmeno una buona storia di fallimento, perché non ci insegna niente sul come fallire, sull’apprendere dai propri errori per costruire qualcosa di solido. Anzi, è una storia di negazione dell’insuccesso, dove la finzione narrativa si discosta sempre di più dalla parabola discendente che sta invece accompagnando la startup rappresentata (la quale, dopo cinque anni di operatività in un ambito – il Digital – che non richiede lunghissimi tempi di incubazione, dovrebbe ormai essere una PMI innovativa a tutti gli effetti). E negare il proprio insuccesso, per quanto doloroso sia stato, è esattamente l’errore in cui un buon imprenditore non dovrebbe mai incappare (come ho già scritto proprio su EconomyUp).
In sintesi questa storia è rischiosa perché, come ha intelligentemente scritto Stefano Mainetti, CEO di Polihub, non aiuta a separare l’hype da quello che di buono c’è nel nostro ecosistema. Ossia continua a confondere una attenzione mediatica – talvolta disinformata – per la “bolla Startup”, con i casi davvero interessanti che l’Italia e gli imprenditori italiani hanno prodotto in questi ultimi anni: sia buoni successi che buoni fallimenti, che portano ad analisi e apprendimento.
Come può tuttavia un film avere un effetto così negativo per le startup in Italia? La risposta è piuttosto semplice: il nostro ecosistema startup hi-tech è giovane e ben lontano dall’essere “tetragono ai colpi di ventura”; e se permane questa confusione, essa presto sfocerà nella disillusione. Tra i tanti disillusi, un commento letto in particolare mi ha colpito: “bisogna smettere di credere nelle Startup e agli startupper”.
Questa frase mi ha fatto riflettere sul concetto di fiducia e di speranza intorno alle startup. E mi ha riportato alla memoria un altro film recente, di un genere completamente diverso: “Rogue One”, l’ultimo (sotto)capitolo della saga di Star Wars. I film di Star Wars possono essere interpretati con diverse chiavi di lettura: la lotta tra il bene e il male, lo Yin e lo Yang; il percorso ciclico che porta dalla dannazione alla redenzione; il concetto di nemesi, che si riunifica sotto la “Forza” che tutto permea. Ma guardandoli attraverso la prospettiva originale delle startup, credo possano emergere spunti interessanti.
Rogue One è la storia non ancora narrata dei ribelli che trafugano i piani per distruggere la Death Star, la Morte Nera, una stazione di battaglia dell’Impero Galattico in grado di annichilire un intero pianeta. Questa storia insiste su un principio cardine: “le ribellioni si fondano sulla speranza”.
In fondo, la startup è caos, è ribellione: contro le regole del gioco, contro lo status quo, contro un sistema che sembra inerziale e incapace di sostenere l’innovazione radicale. Senza speranze e senza sogni, le startup di fatto sono morte sul nascere: per questo non possiamo permetterci di “smettere di credere” in esse e nel loro potenziale innovativo.
Qui però viene il bello: alla speranza, motore primo di ogni startup, si deve aggiungere la concretezza, quella capacità di execution che fa passare il valore dell’idea da 1 dollaro a 1 milione (o addirittura 1 miliardo) di dollari. Se la startup resta soltanto un’idea affascinante senza volontà e capacità di metterla in pratica, si perderà nel limbo dei progetti incompiuti.
Ed anche qui Rogue One ci mostra come alla speranza in un futuro migliore si debba fare seguire l’azione. Jyn Erso e Cassian Andor, i protagonisti, non si astengono mai dalla lotta, e nonostante contrasti interni e obiettivi che cambiano in maniera inaspettata a fronte della turbolenza del contesto in cui si muovono, guidano il loro “team” verso la missione finale – l’attacco a sorpresa al centro informativo dell’Impero sul pianeta Scarif. Un team variegato, composto da un’improbabile accozzaglia di uomini e donne con skill diverse, lì come volontari. Pronti a giocarsi tutto in nome di un’idea e di una speranza.
Anche il nome stesso della navetta imperiale rubata utilizzata per trasportarsi sul luogo la missione, appunto Rogue One, per quanto venga scelto quasi per caso è estremamente evocativo: gli startupper stessi in gergo sono spesso definiti (o si definiscono, non senza un certo autocompiacimento) hustler, pirate o rogue trader.
Rogue One, la navetta spaziale, diviene quindi metafora della startup, il suo equipaggio fatto dal gruppo di fondatori e dal loro seguito. Da quel momento in avanti, la missione procede identificando costantemente opportunità e cercando di coglierle allorché si presentano, perfetta sintesi dello spirito imprenditoriale.cE prima che il portello si apra e tutto abbia inizio, sono ancora le parole di Jyn alla sua squadra a illuminare la via: “We’ll take the next chance, and the next, until we win, or the chances are spent.”
Testare, provare, riprovare, per avere successo o eventualmente fallire nel tentativo: l’approccio che anima l’operato di ogni vero startupper.
Anche un apparente fallimento della tragica ma fiera missione potrà portare poi ad un successo nel futuro – che non vedrà nemmeno necessariamente coinvolti gli stessi protagonisti della prima avventura (d’altronde si sa, il team può cambiare): potrà donare “a new hope”, una nuova speranza, come i fan di Star Wars ben sanno.
Perché le startup scardinano, rompono, e magari si rompono esse stesse in questo convulso processo: ma lasciano un segno, un seme. La startup è stardust, è fatta di speranze e di sogni; ma se al sogno segue l’azione, quel seme può cambiare le sorti di un impero.
Quindi volete vedere un film che vi parli davvero dell’esperienza startup? Guardatevi “Rogue One: a Star Wars story”.
* Antonio Ghezzi è Direttore Osservatorio Startup Hi-Tech del Politecnico di Milano