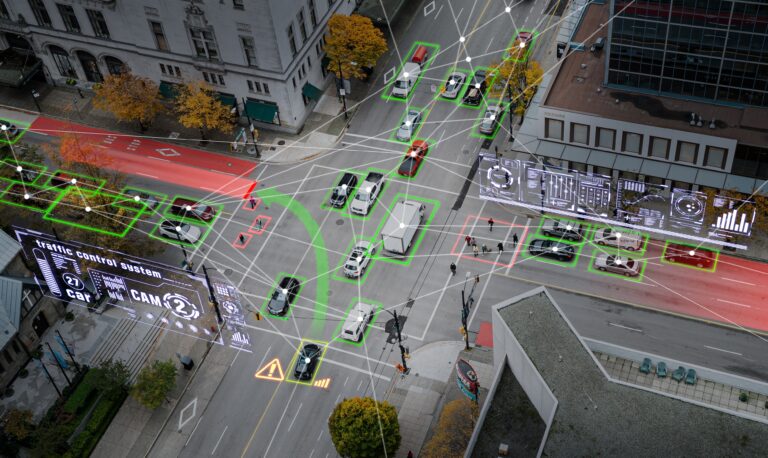Redazioni dove si decidono le notizie da scrivere sulla base dei topic trend del momento su Internet. Dove è possibile sapere con esattezza quanto è stata letta (e apprezzata) una notizia in un determinato giorno di una determinata ora (e seguirne l’andamento nel corso del tempo). Dove il giornalista, oltre a essere produttore, diventa distributore del suo prodotto editoriale, e magari sceglie di mettersi in proprio dopo aver scoperto che è in grado di generare la maggiore parte del traffico della testata per cui scrive. E dove il direttore arriva a tagliare la costosa retribuzione di un editorialista di grido dopo aver scoperto che genera meno interesse di un blogger 18enne.
Scenari avveniristici per l’editoria italiana? No, una realtà dietro l’angolo, che è in grado di concretizzarsi grazie all’uso dei Big Data, almeno secondo Claudio Zamboni (nella foto), co-founder e partner di 3rdPLACE, società di strategie di marketing digitale. “Ma l’editoria italiana – puntualizza l’esperto di digital intelligence – non sta ancora cogliendo l’opportunità dell’innovazione. Se lo facesse assisteremo non solo a uno stravolgimento del modo in cui lavorano le newsroom, ma anche dell’intera organizzazione aziendale. Io però dico che, per chi non introdurrà i Big Data nella gestione editoriale, la domanda non è se morirà, ma quando morirà”.
In che modo l’analisi dei flussi di dati su Internet potrà stravolgere le aziende editoriali?
Esistono software interni in grado di individuare in tempo reale quali sono i trend topic verticali su Internet. Non mi riferisco ai trend generalisti, ovvero al mare magnum di Twitter e Facebook dove si parla un po’ di tutto, mi riferisco ad analisi su contenuti verticali: è cioè possibile a tutt’oggi individuare nell’ambito dell’economia o della politica o dello sport quali sono gli argomenti top derivanti dall’insieme di tweet e post su Facebook degli utenti su quei determinati argomenti. Quali le conseguenze? Oggi nei giornali si decide di scrivere su un determinato tema ricorrendo a metodi tradizionali quali la percezione soggettiva, l’esperienza accumulata sul campo o scelte editoriali ben precise, invece attraverso la gestione dei Big Data si può scoprire che milioni di persone sui social sono interessate a un altro.
Cosa può comportare questo per l’organizzazione di una newsroom?
Cambiamenti sostanziali. Perché oltre alla tradizionale riunione di redazione tutte le mattine, dove si decide quali saranno i topic del giorno con scelte “dall’alto”, ci potrebbe essere una parte della redazione che, dal “basso”, intercetta in tempo reale questi input, questi trend verticali, per poi condividere con il caporedattore l’opportunità di sfruttare o meno gli esiti della ricerca. Ma è solo un piccolo esempio dell’utilizzo dei Big Data nell’editoria.
Ce ne sono altri?
La possibilità di aggregare dati attualmente provenienti da fonti diverse. Mi spiego: una qualsiasi delle nostre testate giornalistiche più note, penso a Repubblica o al Corriere della Sera, è dotata di sito Internet, app, mobile site e ha una forte presenza su Facebook e Twitter. I dati analitici che si riferiscono ai pattern di navigazione degli utenti attraverso il sito, l’app e il mobile site sono però su repository, cioè su “cassetti”, diversi. I dati di navigazione di un utente che entra nel giornale attraverso il sito sono in un cassetto, quelli dello stesso utente che passa dal mobile site in uno diverso, i dati sui comportamenti del medesimo utente su Facebook sono all’interno delle metriche di Facebook. Di fatto la grandissima quantità di dati oggi a disposizione provenienti da fonti diverse sono in mondi diversi, hanno significato diverso, peso diverso ed è estremamente difficile analizzarli. Il primo passo da fare è portare questi dati, che sono in cassetti differenti, in un unico cassetto, e individuare eventuali correlazioni tra di essi, per poi disporre di ulteriori leve per raggiungere un obiettivo. Per esempio: se so che la crescita di fans su Facebook determina l’aumento di visite ad un sito secondo una relazione matematica ben precisa, potrà risultare utile attivare la costruzione di una massiva audience sul social network. E questo si può fare attraverso software di gestione dei Big Data.
Quali altre opportunità dalla digital intelligence?
L’introduzione del concetto di misurabilità in una fase di pianificazione manageriale, che l’editoria tradizionale non conosce. L’editoria infatti prima del web non era in grado di tracciare la distribuzione di un singolo articolo, all’interno di un prodotto editoriale come un quotidiano. A ogni giornalista oggi potrà essere attribuito un obiettivo di pagine viste su base trimestrale. Di recente ho incontrato il direttore di un’importante testata italiana e gli ho chiesto: “Cosa farebbe se scoprisse che il suo editorialista più importante, che guadagna mezzo milione di euro all’anno, è molto meno letto, cioè sviluppa meno pagine viste e meno visite, di un blogger 18enne non retribuito?”. Mi ha risposto: “Il giorno dopo andrei a ridiscutere il contratto con quel signore”. Il fatto di sapere quanto vale economicamente la raccolta di un articolo rispetto a un altro è un elemento importante di ottimizzazione della gestione aziendale.
Non c’è il rischio che i giornalisti diventino schiavi della Rete, o magari una sorta di operai a cottimo della notizia?
Condivido questa preoccupazione. E ritengo che l’editoria non debba essere completamente data-driven. Ci sono altre logiche: logiche redazionali o di adesione a un certo indirizzo editoriale. Per esempio un editore può decidere di scommettere su un settore informativo di nicchia, che al momento ha un ritorno scarso, ma lo fa perché lo ritiene importante e perché è convinto che alla lunga la scelta pagherà. Il problema è che oggi i manager delle aziende editoriali prendono decisioni poco consapevoli: siamo d’accordo che i numeri non debbano guidare tout court una scelta, ma possono costituire uno degli elementi decisionali sulla base dei quali compiere le scelte. Lancio una provocazione: permetteteci di dare vantaggio a questi numeri che finora hanno governato davvero poche decisioni. Attualmente la situazione è del tutto ribaltata: si ignorano i numeri, si adottano altri criteri.
Lei parla di misurabilità delle notizie. Ma nelle testate online non si cerca già un quotidiano riscontro sulla lettura delle news pubblicate, per esempio attraverso Google Analytics?
In effetti è uno degli strumenti più usati, il 63% dei siti mondiali adopera Google Analytics. Poi ci sono testate che usano altri sistemi di tracking. Ma Google Analytics misura soltanto ciò che avviene all’interno di un sito. Facciamo un esempio: si dimette il Papa e 7 milioni di persone vanno contemporaneamente su Google e digitano il nome del Pontefice dimissionario. Con un investimento di qualche decina di migliaia di euro un editore può intercettare tutti coloro che hanno compiuto questa azione e portarli sul suo sito. Ma dentro Google Analytics quell’editore non rintraccerà il cost per click che ha avuto su Google. Vedrà, in pratica, solo un “pezzettino”. Allo stesso modo, non potrà associare questo costo di acquisizione ad un valore della qualità del traffico acquisito. Ed è questo l’elemento di sofisticazione dei Big Data: sono in grado di integrare dati che provengono da n fonti differenti. In sostanza: finora era una visione in 2D, a due dimensioni. Oggi è arrivato il 3D, la terza dimensione. È possibile ottenere un unico grafico multidimensionale con il numero di pagine viste, gli utenti unici, il tempo speso dal giornalista per scrivere un determinato articolo. Insomma una serie di metriche qualitative e quantitative. Questi dati possono essere incrociati con il costo orario del giornalista e la raccolta pubblicitaria sull’articolo.
Ripeto: e il giornalista? È la sua fine? O perlomeno la fine di un modo di pensare il giornalismo?
Il giornalista ha un ruolo molto difficile da sostenere perché tutto questo investe in maniera drammatica la riorganizzazione e le competenze aziendali. Oggi la produzione non è più separata dalla distribuzione, quindi chi scrive si deve occupare anche della distribuzione. E deve essere in grado di connettersi con gli influencer, cioè coloro che sui social network fanno opinione su determinati argomenti, in modo da crearsi un’audience di riferimento, corredando i propri contenuti dei necessari strumenti tecnici per risultare visibili (tecniche di scrittura e metadati per risultare visibili sui motori e nei social network). Allo stesso tempo ci sono anche delle opportunità per chi fa questo mestiere: negli Usa sono state lanciate aziende da giornalisti che si erano resi conto di generare, grazie ai propri articoli, il 70/80% del traffico di un sito. In pratica si sono messi in proprio, in alcuni casi hanno anche inserito il paywall e stanno andando alla grande.
Ma se i Big Data sono realmente in grado di stravolgere l’editoria, perché ancora non si usano a sufficienza, almeno in Italia?
Perché è una materia nuova, estremamente complessa. E i manager di 60 o 70 anni che dirigono le aziende editoriali hanno difficoltà a decodificare le informazioni. Di fatto le aziende editoriali italiane hanno cavalcato il digitale e cercato di rinnovare l’esistente, ma la vera rivoluzione digitale deve portare a un nuovo tipo di azienda che produce un nuovo tipo di organizzazione, che a sua volta dà vita a nuovi modelli distributivi e a nuovi prodotti. Questo paradigma possono adottarlo solo quelle che sono, non dico native digitali, ma le cui competenze attingono fortemente agli ultimi 15 anni di rivoluzione digitale.