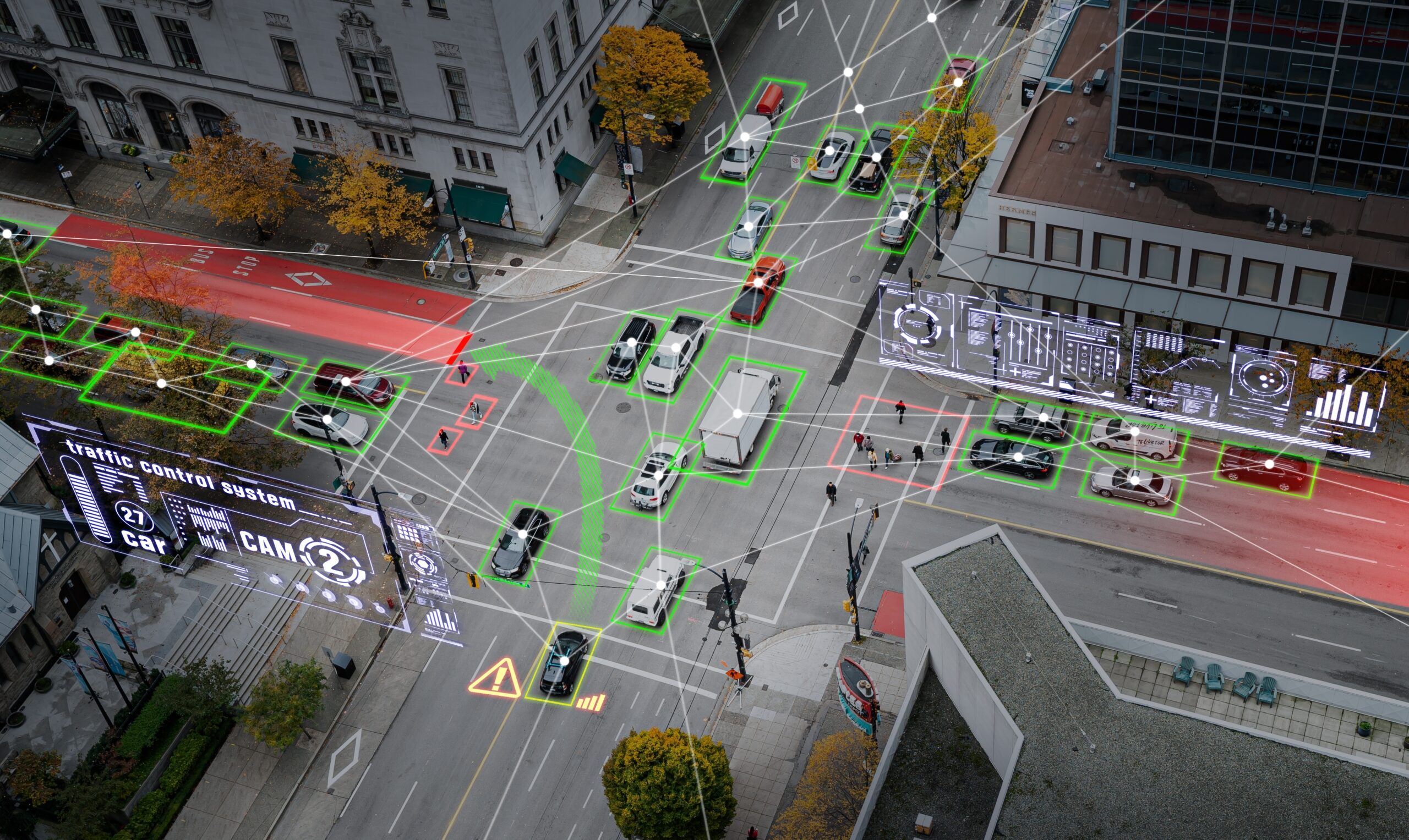Una certificazione volontaria del made in Italy, pensata per le aziende italiane, soprattutto quelle piccole e medie, che contribuisca alla promozione dei nostri prodotti di qualità nel mondo: è la proposta contenuta in un disegno di legge presentato a fine novembre dalla vicepresidente del Senato Valeria Fedeli e dal presidente della commissione Industria, Massimo Mucchetti. L’idea è questa: lo Stato dà la possibilità alle aziende del nostro Paese di richiedere una sorta di “bollino blu”, a costo zero per l’imprenditore, da utilizzare per qualificarsi a livello internazionale come eccellenze nostrane.
Non ci sono già tanti tipi di certificazione? Perché un nuovo marchio made in Italy?
Perché l’Italia deve tornare a reinvestire sulla propria manifattura e sulla propria industria. In particolare bisogna che parlamento, governo e forze economiche ricomincino a puntare sulla qualità delle produzioni italiane. Non è mai stato automatico, e non lo è nemmeno adesso, pensare che produrre in Italia significhi qualità. Chi lo fa nei sottoscala o con materiali scadenti non ci interessa ai fini del rilancio del made in Italy. Ma per pubblicizzare la qualità italiana bisogna partire dall’Europa.
In che modo?
L’Unione europea da tempo è impegnata sulla materia, ma ancora non è approdata a nulla di concreto. Attualmente l’articolo 7 del Regolamento europeo, definito il 17 ottobre 2013 in Commissione mercato interno, stabilisce che debba essere emanata una legge europea in cui si definisca l’obbligatorietà di etichettatura dei prodotti importati e di quelli che circolano in Europa. Ma ancora questa legge non c’è, lo sappiamo.
Sappiamo invece che, in base alle regole internazionali del commercio mondiale, a tutt’oggi in vigore, è obbligatoria l’indicazione di origine nelle etichette.
Riassumendo: allo stato dei fatti qualsiasi merce che entra in Europa non ha l’obbligo di indicazione di origine. Al contrario, se un nostro prodotto viene esportato in Usa o in Cina, in quei Paesi vige questo obbligo. Invece serve reciprocità delle regole del commercio internazionale, una battaglia che conduciamo da tanti anni. L’Europa in questo contesto è fondamentale perché le politiche commerciali le deve definire la Ue, non i singoli Paesi. Ma noi italiani intanto facciamo la nostra parte.
Il Made in Italy, secondo statistiche internazionali, è il terzo brand più desiderato al mondo dopo Coca-Cola e Visa. C’è davvero bisogno di un provvedimento che lo rafforzi?
Ce n’è bisogno per puntare seriamente, e sempre più, sulla qualità. Al momento certifichiamo un prodotto come “made in Italy” se l’ultima trasformazione sostanziale è stata fatta in Italia. Basta aggiungere un bottone particolare a un vestito tessuto all’estero e questo può circolare nel mondo come “prodotto in Italia” in base alle leggi di origine doganale. Noi, con questa proposta, vogliamo aggiungere un ‘pezzetto’ in più e garantire una fase ulteriore prima dell’ultima fase di trasformazione che dà origine al made in Italy, oltre a verificare, per esempio, che le aziende non usino prodotti nocivi nei processi produttivi.
Come dovrebbe funzionare?
Innanzitutto chiediamo la collaborazione e la condivisione di chi produce. Le leggi hanno effetto se sono condivise con chi poi dovrà adottarle. Inoltre ogni comparto ha le sue regole: il mio disegno di legge prevede disciplinari attuativi diversi settore per settore.
E le aziende che hanno già certificazioni di qualità (penso ai Dop, ecc. ecc.)?
Possono rientrare in questo contesto. Il marchio made in Italy “statale” non fa che arricchire il bouquet di certificazioni di un’impresa.
Ma perché lo Stato dovrebbe occuparsi di marchi?
Perché è una parte importante della politica commerciale del nostro Paese. Perché, introducendo un marchio volontario, non si finisce in contrasto con le direttive Ue. E per promuovere il mercato. Per ora la promozione la fanno e l’hanno sempre fatta più che altro le grandi aziende internazionalizzate – e dico per fortuna del Paese – ma l’80% delle nostre filiere manifatturiere produttive sono pmi e non hanno la possibilità di effettuare investimenti così ampi per la promozione internazionale.
Chi potrà accedere alla richiesta di questo marchio collettivo volontario?
Chi ha il domicilio fiscale in Italia. Questo dimostra la serietà di una nazione: se si utilizzano fondi pubblici, ovvero i soldi di tutti i cittadini, non si possono dare a chi poi paga le tasse da un’altra parte o dà lavoro altrove. È un discorso di seria politica industriale. Da qui a fine gennaio è in atto una consultazione pubblica sul disegno di legge con tutti i soggetti interessati. Siamo pronti ad ascoltare dubbi e critiche. La decima Commissione del Senato aprirà un link per raccogliere le proposte di modifica.
A chi spetterà la verifica del “bollino di qualità” delle imprese?
Costituiremo un organismo indipendente, promosso dal Ministero per lo Sviluppo economico, che farà le certificazioni e anche le verifiche. Se qualcuno ha ottenuto il “bollino”, ma poi risulta inadempiente a seguito delle verifiche, per alcuni anni non lo potrà più richiedere.
In definitiva qual è il valore aggiunto della vostra proposta?
La campagna promozionale che fa il Paese per il suo settore industriale. Si aprirà un portale istituzionale con i nomi delle filiere e delle aziende che si sono volontariamente certificate. Ci saranno campagne internazionali di promozione. Oggi sempre più consumatori vogliono la certezza della qualità.
Quanto costerà alle aziende?
Zero. La promozione la deve fare il governo. La dotazione finanziaria prevista è 5 milioni di euro: oggettivamente non sono molti, ma contiamo che possano aumentare. L’errore italiano negli anni precedenti era proporre un marchio obbligatorio, invece serve la volontarietà. In Francia ne stanno discutendo, in Germania ce l’hanno da sempre. Tutto questo servirà anche ai grandi marchi, perché avranno la possibilità di dimostrare che non stanno producendo tutto in Cina o in Vietnam e poi l’ultimo passaggio lo fanno in Italia. La normativa potrà servire a contrastare anche il cosiddetto Italian Sounding, cioè i prodotti che fingono di essere italiani.
Non sarà un ulteriore carico di burocrazia per le imprese?
La procedura dovrà essere agevole, chiara e facile. Bisogna togliere le logiche burocratiche in un’ottica di semplificazione. Per esempio si può pensare di concedere la certificazione a chi la chiede e in seconda istanza procedere alle verifiche. Lo scopo finale resta quello di sostenere competitività, qualità e reputazione del Made in Italy.