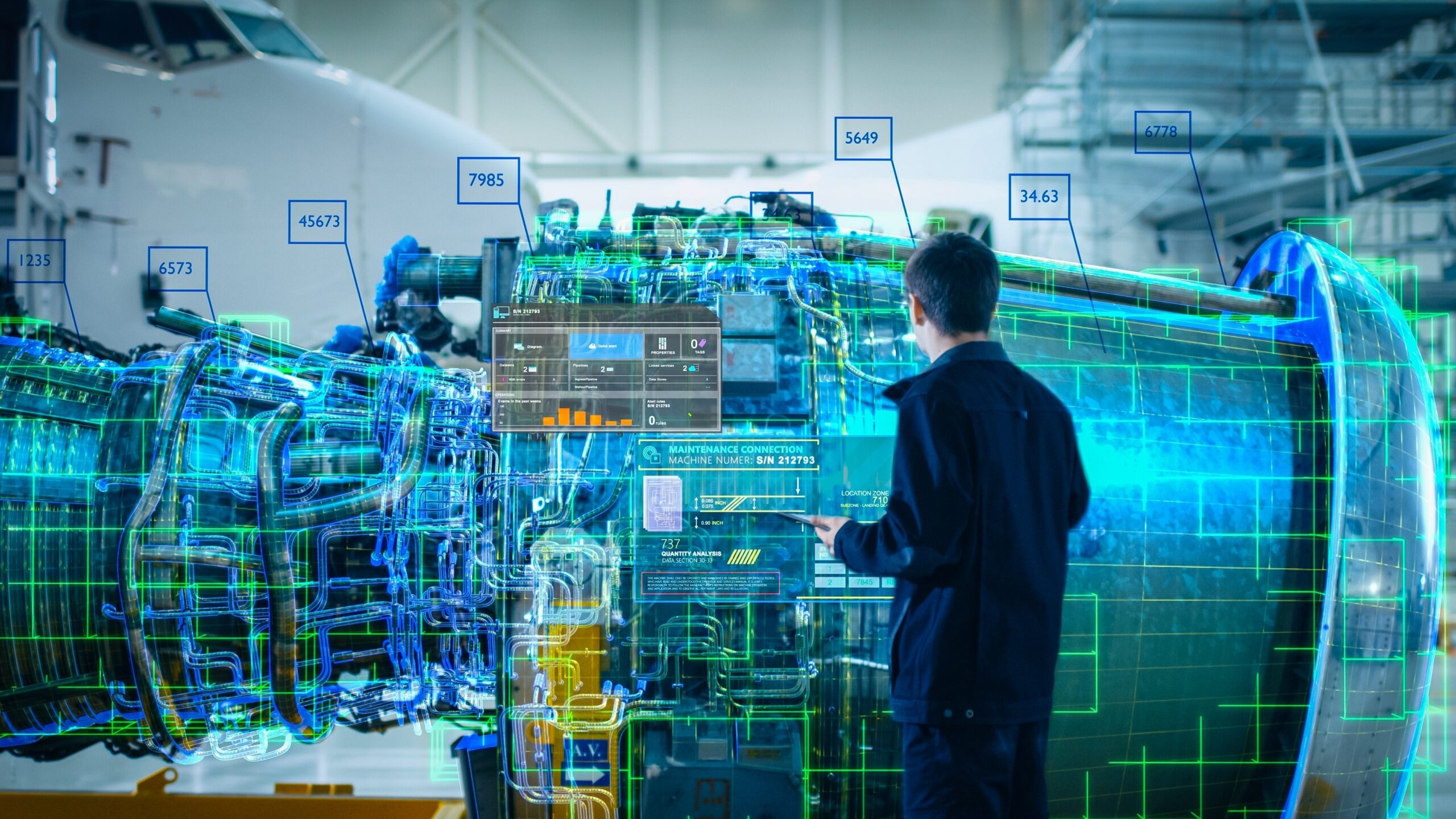Torna a casa, made in Italy. Dopo aver preso la strada dell’Europa orientale o del Sudest asiatico per ridurre i costi, alcune aziende italiane scelgono di fare la strada al contrario e reinsediare tutta la produzione, o solo alcune parti, nel nostro Paese. Il fenomeno, per fare il verso alla tanto vituperata delocalizzazione, può essere definito rilocalizzazione oppure back-reshoring. Secondo Uni-CLUB MoRe Back-reshoring, il gruppo di ricerca interuniversitario che si occupa di studiare questa dinamica, durante il periodo della crisi si sono registrati almeno dieci casi di rilocalizzazione all’anno.
Torna a casa, made in Italy. Dopo aver preso la strada dell’Europa orientale o del Sudest asiatico per ridurre i costi, alcune aziende italiane scelgono di fare la strada al contrario e reinsediare tutta la produzione, o solo alcune parti, nel nostro Paese. Il fenomeno, per fare il verso alla tanto vituperata delocalizzazione, può essere definito rilocalizzazione oppure back-reshoring. Secondo Uni-CLUB MoRe Back-reshoring, il gruppo di ricerca interuniversitario che si occupa di studiare questa dinamica, durante il periodo della crisi si sono registrati almeno dieci casi di rilocalizzazione all’anno.
Se facciamo partire il contatore dal 1997, anno in cui si sono osservati i primi dietrofront, le operazioni di back-reshoring fino al 31 dicembre 2013 raggiungono quota 79. Non una cifra che può far gridare al miracolo, certo, ma sufficiente per capire che si tratta di qualcosa di più di una semplice coincidenza.
“Ecco perché le aziende tornano a produrre in Italia“
I motivi del rimpatrio sono numerosi. Lontano da casa, per esempio, i costi della logistica tendono ad aumentare, la differenza nel costo del lavoro non è più abissale come prima, e la qualità della manifattura è inferiore rispetto a certe eccellenze del nostro Paese. Inoltre, il made in Italy, inteso come produzione italiana al 100%, è sempre più richiesto dal mercato. Se ci aggiungiamo anche che la distanza tra sedi produttive all’estero e centri di ricerca e sviluppo in Italia non permette di rispondere immediatamente alle variazioni del mercato, si capisce perché l’idea di rilocalizzare diventi progressivamente più allettante, anche al netto di tutti gli ostacoli (fiscali, burocratici e di sistema) che rendono difficoltoso il fare impresa nel Belpaese.
Ecco dieci casi di aziende che sono ritornate a produrre in Italia.
And Camicie è un marchio di camiceria che fa capo al gruppo Columbia di Mirano (Venezia). L’azienda produceva in Cina per servire il mercato locale. Nel 2013, la società ha stretto un accordo con uno degli uomini più ricchi della Terra di Mezzo, Zong Qinghou (11,5 miliardi di dollari di patrimonio), a capo del Wahaha Group, un colosso del settore beverage che progetta di aprire 20 nuovi centri commerciali (denominati Waow Plaza) in diverse città cinesi. L’intesa prevede che il produttore veneto di camicie possa aprire all’interno di questi 20 mall altrettanti negozi monomarca. Ma a una condizione: la produzione dei capi deve avvenire interamente in Italia, perché la nuova classe media cinese, molto più esigente che in passato, accetta di spendere di più per un prodotto italiano solo se questo è made in Italy al 100% e la qualità è impeccabile. Così, la camiceria veneta ha rilocalizzato in Italia le produzioni destinate al mercato cinese. Certo, la merce in vendita in Italia viene invece prodotta in Romania per tenere bassi i costi. Ma dall’azienda assicurano che in caso di sforbiciate del costo del lavoro da parte del governo, altre produzioni potrebbero essere ritrasferite in Italia.
Aku è un produttore veneto di calzature da trekking e outdoor che, dopo aver portato gran parte della produzione in Romania, nel 2010 ha deciso di riaprire lo stabilimento di Montebelluna (Treviso) per realizzare i modelli di qualità più alta. Il caso dell’azienda trevigiana è significativo anche perché l’intero settore dell’abbigliamento sportivo made in Italy si è dimostrato particolarmente sensibile all’inversione di rotta. Sono diverse infatti le imprese del comparto che hanno optato per il back reshoring. E nella loro scelta ha sicuramente avuto peso la moral suasion fatta da Assosport, una delle associazioni di categorie che più si sono spese con i propri associati per favorire il controesodo.
Masters è un’altra azienda attiva nel ramo dell’abbigliamento sportivo (iscritta ad Assosport) che ha deciso di tornare sui propri passi e ri-insediare alcune lavorazioni in Italia. La società, tra le maggiori al mondo per la produzione di bacchette da sci, trekking e nordic walking ha ritrasferito nel 2013 a Bassano del Grappa (Vicenza) la realizzazione dei tubi in alluminio che prima era stata spostata in Cina.
Fiamm è il maggior produttore italiano di batterie per automobili. Negli anni scorsi aveva aperto stabilimenti in India e in Repubblica Ceca. Nel primo caso, aveva dato vita a una joint venture per servire il mercato locale, ma ha deciso di riportare in Italia la produzione a causa di una domanda di mercato non soddisfacente e di una manodopera del posto non abbastanza qualificata. La Repubblica Ceca era stata scelta invece per produrre batterie stazionarie ma anche in questo caso, visto che il personale del posto non riusciva a raggiungere gli standard di qualità italiani, l’azienda guidata da Stefano Dolcetta ha scelto di fare dietrofront. Concentrare il più possibile le lavorazioni in pochi stabilimenti fa parte anche di un piano strategico secondo il quale la produzione e la ricerca e sviluppo devono essere vicini per poter reagire più velocemente alle evoluzioni della domanda e spendere meno possibile per il coordinamento dei reparti. L’innovazione è più efficace se è a chilometro zero.
Nannini è un importante produttore toscano di borse in pelle. La griffe fiorentina, da tre anni a questa parte, ha messo in atto un processo di rilocalizzazione della produzione affidata a terzisti dell’Europa dell’Est. E a partire dalla stagione in corso, la primavera-estate 2014, la collezione sarà interamente prodotta in Italia. I principali motivi del rimpatrio, in questo caso, sono l’eccellenza delle lavorazioni artigianali, che in Italia sono particolarmente pregiate, e la necessità di controllare da vicino la qualità dei prodotti. L’idea forte che passa dalla scelta di Nannini, così come da altre vicende simili, è che il mito del “designed in Italy” come possibile rimpiazzo del “made in Italy” poggiava probabilmente su una concezione sbagliata: il design, pur fondamentale per contraddistinguere l’italianità di un prodotto, non basta a soddisfare il cliente se non è accompagnato dalla qualità del prodotto.
Piquadro, azienda toscana produttrice di borse e valigie, ha preferito l’Italia alla Cina riportando in patria la fascia più alta delle lavorazioni. E l’intenzione è quella di raddoppiare ogni anno la produzione nel Belpaese, che non era mai venuta meno del tutto. Paradossalmente, a spingere l’impresa verso la rilocalizzazione è stato soprattutto l’aumento del costo del manodopera. In Cina, nel settore in cui è attiva Piquadro, i costi del lavoro sono saliti in tre anni di quasi la metà. A conti fatti, i vantaggi del produrre nella Terra di Mezzo vanno quasi a scomparire, anche perché in Italia la manodopera è sì più costosa ma si mantiene relativamente stabile mentre in Cina tende ad aumentare di anno in anno. In più, lo yuan si sta lentamente rivalutando, tant’è che c’è già chi sposta gli stabilimenti verso Paesi vicini come Bangladesh e Vietnam.
Hella Svb, casa piemontese produttrice di abbigliamento femminile, ha deciso di tornare a produrre in Italia dopo aver delocalizzato in Romania. Anche se tuttora l’azienda di Rivalta (Torino) è in difficoltà – risulta in liquidazione dal luglio 2012 – può essere presa in considerazione come esempio significativo perché in questo caso uno degli stimoli a fare marcia indietro è venuto da un particolare strumento di politica regionale: la legge 34 del 2004 della Regione Piemonte, che propone il contratto di insediamento (con finanziamenti, agevolazioni e snellimenti burocratici) per attrarre aziende sul territorio. Naturalmente, l’attrazione non si riferisce solo alle imprese straniere ma anche alle italiane “emigrate”. E il rimpatrio della Hella Svb è la dimostrazione che per facilitare il back reshoring sono necessari anche interventi efficaci di politica industriale.
Natuzzi è un noto marchio dei divani made in Italy. L’azienda pugliese ha firmato nel 2013 un accordo, definito “storico” da parte dei sindacati coinvolti nelle trattative, che prevedeva il ritorno in Puglia e Basilicata di alcune produzioni di fascia alta effettuate in Romania. La decisione ha permesso all’impresa di ridurre il numero di esuberi previsti, di ri-occupare centinaia di lavoratori che diversamente sarebbero rimasti senza impiego e di creare ulteriore lavoro per le imprese dell’indotto.
Belfe, storica azienda veneta di abbigliamento, ha una storia meno edificante ma di non minor interesse rispetto a quelle delle altre imprese che si sono ristabilite in Italia. Dopo aver operato in Asia (tra Cina, Indonesia e Vietnam) nel 2004 ha scelto di riportare le produzioni in Europa, tra Italia e Bulgaria. Nel 2012 ha deciso però di chiudere lo stabilimento di Marostica (Vicenza) e di concentrare tutte le lavorazioni in Bulgaria. La vicenda merita particolare attenzione perché dimostra che la rilocalizzazione è un fenomeno mutevole nel tempo e si lega a doppio filo con il cosiddetto near reshoring: le aziende lasciano il Far East ma anziché tornare nel Paese di partenza – in questo caso, l’Italia – si insediano in Paesi vicini.
Wayel, azienda emiliana specializzata in bici elettriche, ha ritrasferito dalla Cina a Bologna la sua produzione. Per produrre le e-bike, l’impresa, che fa parte del gruppo della climatizzazione Termal, realizzerà uno stabilimento a impatto zero denominato FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), che darà impiego a 39 persone: l’investimento previsto è di 12 milioni di euro. Il prodotto di punta sarà Solingo, un ciclomotore elettrico con batteria solare. In questo caso, a far optare verso la delocalizzazione al contrario sono stati soprattutto la vicinanza con i mercati nord-europei (i più interessati alle bici elettriche) e la possibilità di fare ricerca a contatto con l’Università di Bologna.