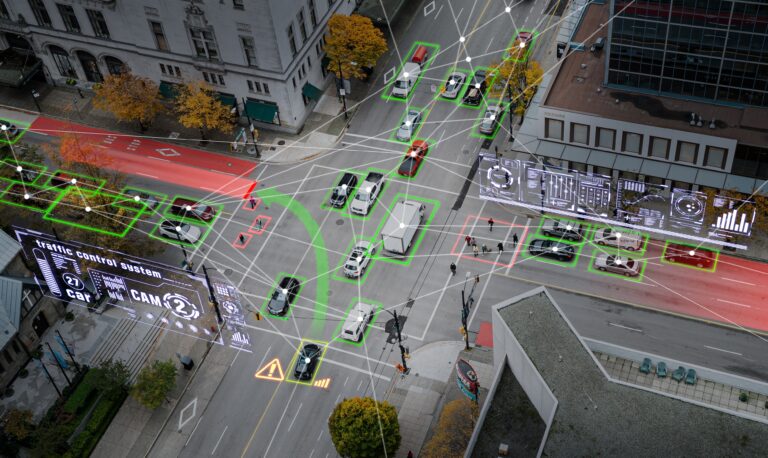Nel mio articolo sul libro di Mariana Mazzucato, pubblicato su EconomyUp.it il 29 marzo scorso, sostenevo che nella versione estrema della teoria economica neoclassica Stato e Sindacato sono i due nemici principali del benessere dei cittadini. In quella sede passavo poi ad occuparmi, ovviamente, del ruolo dello Stato nell’economia, visto il ruolo che lo Stato ha nel modello, e nei fatti, esposti da Mazzucato, omettendo volutamente di parlare di Sindacato. Del quale voglio cominciare a parlare oggi.
1. IL SINDACATO NELLE ECONOMIE DI MERCATO: LA VISIONE DELLA TEORIA DOMINANTE
Partiamo dal pensiero economico dominante al suo livello più astratto, quello appunto della teoria economica neoclassica (che è dominante non nel senso che è ‘migliore’ rispetto alle altre, ma perché ‘domina’, cioè guida, il pensiero politico ed economico dominante – ivi incluso il pensiero pro-stagnazione, noto anche come austerità.
(Per chiarire in che senso questa teoria sia ‘dominante’ è forse utile ricordare che tutti i governi recenti di questo Paese hanno aderito senza eccezione e senza remore a questa visione del mondo, operando attivamente per il progressivo svuotamento dei poteri delle rappresentanze sindacali nei processi di contrattazione del salario e delle condizioni di lavoro. L’ultimo tentativo in questo senso in ordine di tempo è la normativa chiamata, chissà perché in inglese, Jobs Act).
Ora, secondo la teoria neoclassica Il più alto livello di benessere che l’individuo e la comunità economica possano raggiungere è quello generato dal libero funzionamento del mercato, in particolare del mercato del lavoro. Se, dice la teoria neoclassica, lavoratori e imprese sono liberi di contrattare individualmente le condizioni salariali e di lavoro, allora il meccanismo della domanda (da parte delle imprese) e dell’offerta (da parte dei lavoratori) di lavoro assicurerà che tutti coloro che vogliono lavorare al salario corrente troveranno lavoro: in breve, il mercato genera piena occupazione. Il meccanismo è presto descritto. La domanda di lavoro aumenta al diminuire del costo del lavoro poiché, a parità di capitale impiegato, il contributo del lavoratore marginale (ultimo occupato) al valore della produzione è minore rispetto a quello di tutti i lavoratori precedentemente assunti e impiegati. E le imprese continueranno ad assumere fino a quando l’ultimo lavoratore impiegato produrrà valore pari al costo che egli/ella rappresenta per l’impresa. Ne consegue che chi è disoccupato lo è semplicemente perché non accetta di lavorare al salario corrente, quello del lavoratore marginale, appunto: tutta la disoccupazione è volontaria (da cui la perla “il lavoro c’è, basta accontentarsi”).
È ora chiaro in che senso nella versione ‘pura’ dell’economia di mercato il Sindacato rappresenti un nemico. Esso infatti si sostituisce al singolo lavoratore nel processo di contrattazione, con l’obiettivo di porre un ‘pavimento’ al di sotto del quale le retribuzioni non scendano. Da cui la seconda perla del pensiero debole: è il Sindacato a creare disoccupazione tenendo i salari degli occupati artificialmente alti, e danneggiando quindi tanto le imprese quanto i lavoratori che non rappresenta quali i disoccupati, i precari, gli atipici, i giovani, ecc.
2. SINDACATO E DISTRIBUZIONE DEL REDDITO
È risaputo che il Fondo Monetario Internazionale è da decenni uno degli alfieri più importanti della bandiera del pensiero economico neoclassico – noto nel linguaggio comune come liberismo. Recentemente, in particolare a partire dalla nomina di Olivier Blanchard a capo economista del Fondo e poi con la nomina di Christine Lagarde a suo direttore generale, il Fondo sembra assumere posizioni progressivamente meno monolitiche. Per verificare questa sensazione si possono leggere i lavori di O. Blanchard e compararli a quelli dei suoi predecessori; o forse basta semplicemente comparare due fotografie del Ministro delle Finanze greco, Varoufakis, una con Lagarde e una con Schauble. O, ancora, si potrebbe leggere il lavoro recentemente pubblicato da Florence Jaumotte e Carolina Osorio Buitron, dell’ufficio studi del Fondo, sul rapporto tra ‘forza’ del Sindacato e distribuzione del reddito.
Per apprezzare l’importanza di quest’ultimo lavoro occorre ricordare che la ricerca condotta dagli economisti del lavoro si è finora concentrata, coerentemente con quanto dice la teoria neoclassica e riportato sopra, sugli effetti della diffusione/forza del Sindacato sulla dispersione salariale e sui tassi di disoccupazione per classi di lavoratori. Brutalmente, chi studia il mercato del lavoro si è posto fino ad ora, generalmente, quesiti quali: come aumentano i differenziali salariali tra gruppi rappresentati dal sindacato e gruppi non rappresentati? E che relazione esiste tra forza del Sindacato e disoccupazione dei gruppi non rappresentati?
Jaumotte ed Osorio Buiton assumono una prospettiva più ariosa e meno neoclassica, e si chiedono: che relazione esiste tra forza/diffusione del Sindacato e distribuzione del reddito al livello dell’intera popolazione? In particolare, le autrici pongono il quesito all’interno di quel dibattito aperto da Joseph Stiglitz in svariati articoli e poi sistematizzato nel suo Il prezzo della diseguaglianza, Einaudi 2013, nel quale il problema non è quello neoclassico della dispersione salariale, bensì quello macro della dispersione dei redditi su tutto lo spettro della distribuzione del reddito. In breve, il problema posto da Stiglitz, Krugman e Piketty è quello della crescente concentrazione del reddito nel top 1%, o anche 10%, della popolazione, e quindi del rapporto tra i redditi da lavoro e i redditi da capitale.
L’ipotesi di ricerca delle due economiste del Fondo è che una perdita di potere contrattuale da parte del Sindacato, o una minore ‘densità’ del Sindacato come la chiamano loro, ha tra i suoi effetti più importanti quello della perdita di potere contrattuale di chi lavora rispetto a chi riceve redditi da capitale (il 10% della popolazione con i redditi più alti, appunto). Da un punto di vista contabile questo risultato è ovvio: se la parte del reddito che va al lavoro, qualificato o meno che sia, diminuisce, allora la parte che va ai redditi da capitale deve necessariamente aumentare. Ma da un punto di vista del meccanismo economico si assiste a qualcosa di veramente interessante: ad esempio, “la caduta del potere contrattuale del sindacato consente una più agevole adozione di decisioni aziendali che vanno a beneficio di coloro che in azienda ricevono i redditi più alti, qual è il caso delle decisioni relative a struttura e dimensione del reddito del management.” (Finance and Development, p. 31, traduzione nostra, FS).
A questo punto qualcuno dirà: scoperta dell’acqua calda. Beh, risponderei in due modi:
a. È necessario che l’acqua calda venga riportata frequentemente all’attenzione dei molti, e in particolare dei giovani, poiché altrimenti continueranno a lavarsi con acqua fredda in qualunque condizione;
b. Acqua calda!? Ma se fosse così ovvio, come si spiega il livore antisindacale delle classi medie, quelle che vivono di reddito da lavoro e che vedono la loro quota di reddito prodotto scendere ormai da decenni insieme a quella dei lavoratori non qualificati!? O mi si vuol dire che esse (le classi medie) hanno in mente un modello che spiega il proprio impoverimento, e il progressivo arricchimento del top 10%, con la diffusione e la rappresentatività del Sindacato? Mi piacerebbe leggere (non sentire, leggere) una tale spiegazione.
3. DISEGUAGLIANZE E ALTERNATIVE ALLA STAGNAZIONE
Per quel che riguarda la crisi iniziata nel 2007, i fautori della teoria neoclassica sostengono che essa è un fatto transitorio, e che da essa si esce da un lato con la riduzione del debito pubblico (finora lo hanno aumentato) e con le ‘riforme strutturali’ dall’altro. Nel contesto del nostro discorso le ‘riforme strutturali’ sono la riduzione del costo del lavoro e la progressiva rimozione delle garanzie sindacali, che essi chiamano ‘flessibilità del mercato del lavoro’. La progressiva soppressione del Sindacato agevolerebbe dunque la ripresa economica. (Ovviamente essi non parlano di soppressione del Sindacato, parlano di flessibilità, di Articolo 18, ecc. Come mai abbiano tanto bisogno di flessibilità in un paese con un tasso di disoccupazione del 12% risulta piuttosto difficile da capire, a meno che con la parola ‘flessibilità’ non intendano ‘libertà di licenziare senza dover passare per procedure che implicano un confronto con il Sindacato’).
L’effetto cercato con la soppressione del Sindacato sarebbe, ovviamente, quello di far cadere il costo (e le condizioni) del lavoro a livelli ‘competitivi’. Ma competitivi rispetto a chi? Abbiamo mostrato nella serie ‘I Fatti’, pubblicata negli ultimi mesi su www.scenarieconomici.com, che il costo del lavoro e i salari italiani sono già ben al di sotto di quelli di gran parte dei paesi d’Europa. E abbiamo mostrato anche che sono la produttività, la formazione, l’internazionalizzazione, cioè funzioni tipicamente imprenditoriali, ad essere in sofferenza nelle comparazioni internazionali!
Ma torniamo al tema centrale del rapporto tra distribuzione del reddito e potenzialità di crescita, per poi chiudere tornando al ruolo del Sindacato. La buona teoria economica, insieme al buon senso e a sette anni di disastri economici culminati in tre recessioni nel nostro Paese, insegnano a tutti che la crescita della produzione, dell’occupazione, del benessere, sono il frutto di politiche di crescita della domanda aggregata. Il problema è: cosa c’entra la domanda aggregata con la distribuzione del reddito? Beh, c’entra, e molto. Si immagini un’economia la cui popolazione residente di mille persone possa essere suddivisa nettamente in due soli gruppi: quello di coloro che ricevono redditi da capitale, e quello di coloro che ricevono redditi da lavoro. Si immagini che il gruppo che riceve redditi da capitale sia costituito dal 10% della popolazione e incassi ogni anno il 50% del reddito (numeri, questi, vicini alla realtà attuale). Allora, se il reddito annuo fosse di mille euro, il reddito medio da capitale sarebbe di € 5 e quello medio da lavoro € 1,8. Non è difficile vedere come la probabilità che chi percepisce un reddito da lavoro, € 1,8 l’anno, ne spenderà una quota molto alta per beni di consumo, mentre chi percepisce redditi da capitale ne spenderà una quota più bassa, anche se l’ammontare assoluto della spesa sarà più alta. In sintesi: i poveri consumano e ricchi risparmiano.
Ora si torni alla storia. Come usciamo da questa crisi, spendendo o risparmiando? Mi piace dire che il risparmio è una virtù privata, ma un vizio pubblico. O meglio: nessun problema a vedere tanto risparmio se si vede anche tanta domanda di beni di investimento, il cui acquisto il risparmio serve a finanziare. Ma in una situazione in cui (da anni) la domanda di beni di investimento cade, a che cosa servono quei risparmi? La risposta è semplice: non a finanziare domanda (di beni di investimento). Ma allora da dove viene la domanda se non viene dalle imprese, non può venire dalle famiglie il cui reddito disponibile cade da anni, non viene da un estero rispetto al quale le imprese italiane non sono competitive, e non viene da un governo austero che rifiuta di stimolare la spesa? La risposta è una sola: da una redistribuzione del reddito a favore di chi lavora e spende. E questo è un processo nel quale il Sindacato fa bene (il bene di tutti, anche quello dei percettori dei redditi da capitale!) ad impegnarsi tanto sul piano della rivendicazione salariale quanto su quello della modifica della struttura delle aliquote d’imposta a favore di chi lavora e spende. Una modifica senza la quale la prospettiva di uscire da questa crisi si allontana sempre più.