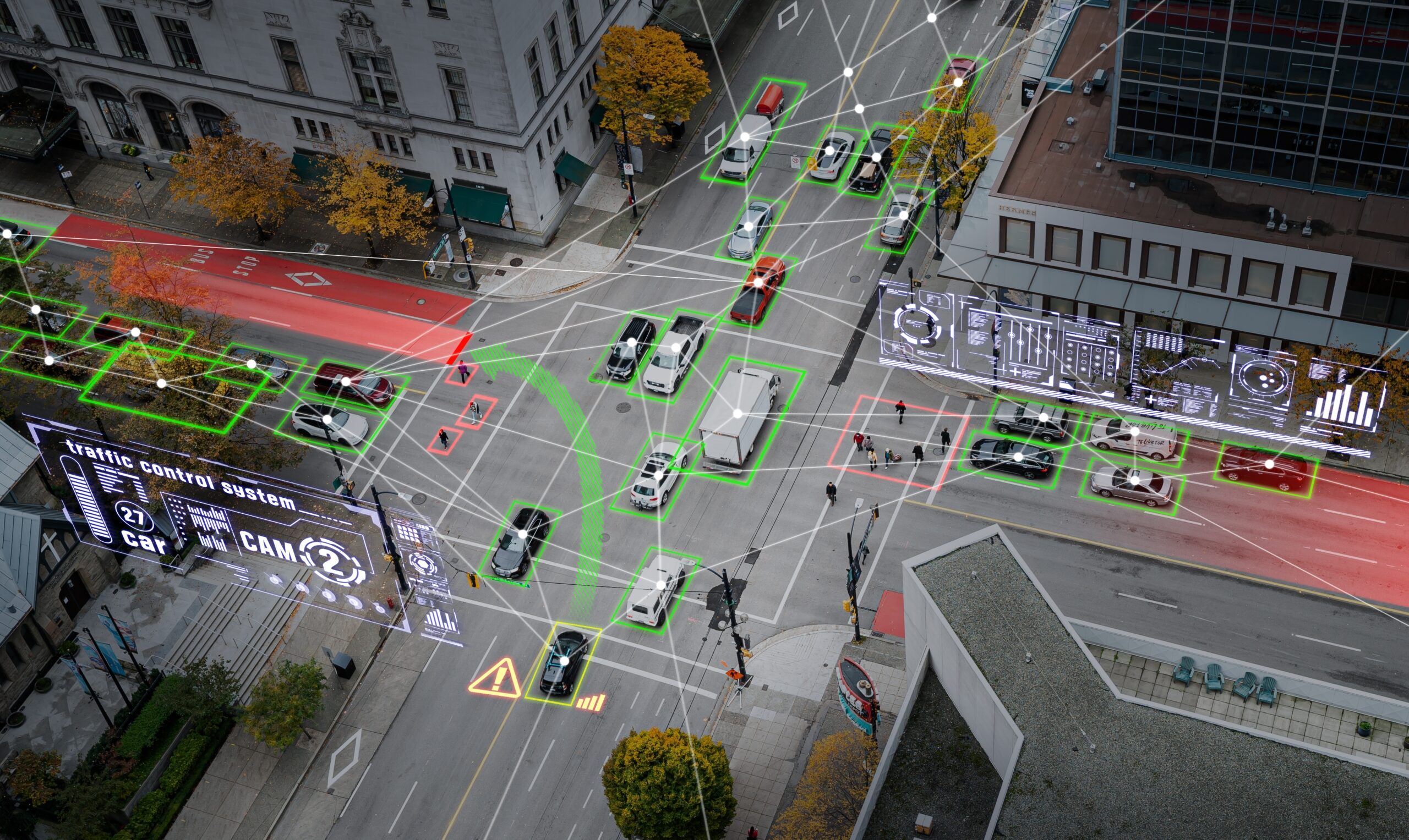Su questo blog ho avviato una discussione su che cosa sia da intendersi per sharing economy, discussione poi evoluta con una riflessione sulla gig economy. Ho cominciato scherzando, tanto è vero che aprivo il mio primo pezzo confessando la mia ignoranza e, ad un tempo, la mia incoscienza a parlare di cose di cui non so. Ma ora mi sto affezionando al tema, e vorrei provare con un altro contributo. Se tale può essere ritenuto.
Venerdi 8 gennaio il dipartimento del lavoro americano ha comunicato che nel mese di dicembre 2015 l’economia di quel Paese ha risucchiato nell’apparato produttivo 292.000 nuovi lavoratori precedentemente da esso esclusi. Un numero enorme, anche per un’economia tanto grande. Questo dato stimola due riflessioni, una più ‘tradizionale’ e una meno.
La prima riflessione ha a che vedere con la politica monetaria Usa. È arcinoto che il 17 dicembre scorso la Fed ha optato per l’aumento del tasso di sconto, il primo da quasi dieci anni. Ed è noto che questa decisione è stata giustificata con argomenti opinabili ma non campati in aria, primo tra tutti il fatto che un’economia in cui l’occupazione cresce tanto velocemente quando già il tasso di disoccupazione è la metà di quello europeo, potrebbe presto mostrare la tendenza ad un aumento dell’inflazione. E un aumento dei tassi aiuterebbe a ‘raffreddare’ il processo nella misura in cui renderebbe un poco più costoso il credito al consumo e quello all’investimento. [Io non credo né al fatto che l’inflazione stia ‘rialzando la testa’, né al fatto che i tassi di interesse siano in grado di influenzare in maniera rilevante la domanda di credito. Ma in questo momento quel che penso io non è oggetto di discussione.] In breve: un aumento tanto rilevante del numero di occupati fa necessariamente aumentare la probabilità che in una delle prossime riunioni dei suoi organi decisionali la Fed decida di varare il secondo aumento. Quanto presto? Non lo so, ma se prima ce lo aspettavamo per l’estate, adesso possiamo aspettarcelo per la primavera.
La seconda considerazione, che pesa sulla prima, è questa. Ricordate quando all’inizio del decennio si parlava di ‘jobless recovery’, ripresa senza nuova occupazione? (Per inciso: sempre negli Usa, perché gli austeri europei erano a quel tempo al loro meglio e godevano della seconda recessione che ci avevano imposto). Il pil cresceva, dunque, senza che il numero di posti di lavoro crescesse altrettanto. Bene, adesso mi chiedo: 292.000 nuovi posti di lavoro? Mentre le stime di crescita del pil Usa vengono riviste al ribasso giorno si e giorno si da mesi!? Come la chiamiamo, questa situazione nuova, ‘occupazione senza crescita’? Non è mica cosa da poco, vedere il valore della produzione complessiva del paese che ristagna mentre l’occupazione aumenta!
E qui mi vengono in testa due pezzi che ho pubblicato recentemente su questo blog, quello sulla sharing e quello sulla gig. Il quesito è: e se un numero rilevante di questi nuovi posti di lavoro pagasse salari nettamente al disotto dello standard salariale pagato a lavoratori ‘tradizionali’, cioè quelli con un contratto, copertura sanitaria, sicurezza sociale, ecc? Voglio dire: e se tra quei 292.000 ce ne fossero tanti che alimentano la gig economy? Perché, vedete, se tanti di questi nuovi posti di lavoro fossero ‘gigs’, allora sarebbe oltremodo ragionevole presumere che la loro retribuzione sarà sub-standard, e che la loro spesa per consumi sarà sub-standard. In soldoni, come si dice: salari bassi, poca domanda aggregata aggiuntiva, bassa crescita del pil. Quadrerebbe: occupazione senza crescita.
La domanda è allora: ma quanti sono questi lavoratori della gig economy? Fortuna vuole (!) che anche stavolta la manìa di contare e quantificare abbia preso il sopravvento sul pensare, e infatti ecco pronta una indagine sull’incidenza della economy on demand sull’occupazione totale. Recentissima, pubblicata proprio in questi giorni, che vi invito quantomeno a scorrere e possibilmente a leggere. I risultati sono strabilianti.
In breve, la società di pubbliche relazioni Burson-Marsteller, l’Istituto Aspen (un ‘think thank’, non so cosa voglia dire la parola) e Time magazine hanno condotto un’indagine campionaria dalla quale si può estrapolare che 45 milioni di americani dichiarano di aver lavorato, o comunque di aver offerto servizi nella cosiddetta economia su domanda, e che di questi ben 14,4 milioni di persone hanno derivato almeno il 40% del proprio reddito erogando gigs, o dichiarano che essi sono la loro principale fonte di reddito o, ancora, che non possono trovare un lavoro ‘tradizionale’.
Inutile dire che questi numeri hanno scatenato un gran dibattito perché ritenuti incredibilmente alti. Tra i fortemente scettici Alan Krueger, a Princeton, che pochi mesi fa aveva stimato che la popolazione coinvolta nella gig economy fosse dell’ordine dello 0,4%; McKinsey, che nel giugno scorso aveva prodotto una stima dell’1% e forse meno della popolazione attiva totale; Larry Mishel, presidente dell’Economic Policy Institute, per il quale questi risultati sono al limite del ridicolo.
Di chi fidarsi? Di nessuno, ovviamente. E perdonando loro perché non sanno di cosa parlano, e sicuramente non parlano della stessa cosa, cioè non usano una definizione comune. Il che non deve farci dismettere il problema, tutt’altro: la crescita della gig economy influenzerà anche le scelte e gli effetti di politica monetaria.