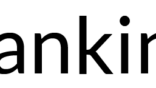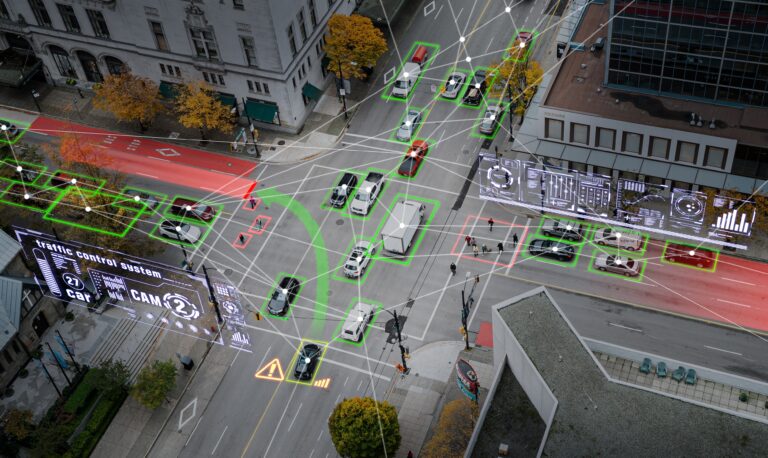“I big data devono essere utilizzati dalle aziende in modo altruistico, perché l’etica fa bene all’economia”. A dirlo in un’intervista esclusiva a EconomyUp è Luciano Floridi, tra i massimi filosofi contemporanei. Le aziende, spiega Floridi, dovrebbero “utilizzare i dati dei clienti con l’obiettivo di semplificare e migliorare le loro vite, non limitarsi a sfruttarli come si farebbe con un giacimento minerario”. Le stesse aziende dovrebbero “analizzare i dati dei dipendenti per comprenderli e supportarli in un percorso di welfare, non per allontanarli se qualcosa non va”. Buonismo anti-economico? “Assolutamente no: l’altruismo dei dati fa apprezzare alla clientela i servizi offerti e al lavoratore il proprio posto”.
Luciano Floridi – romano di nascita e inglese di adozione, professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford, direttore del Digital Ethics Lab e chairman del Data Ethics Group dell’Alan Turing Institute – è la persona giusta per parlare di Human Data Science, modello multidisciplinare che vuole offrire una nuova chiave di lettura dei big data, mantenendo le persone al centro per capire i loro bisogni e verificare come soddisfarli.
Con il consueto linguaggio immaginifico (è ideatore del neologismo onlife, unione di online e offline, poi entrato nell’Enciclopedia Treccani), il filosofo afferma che la tecnologia non è mai neutrale, ma è “un coltello a doppia lama”. Che i processi di data enrichment (arricchimento dei dati unificando e confrontando quelli provenienti da diversi canali) rischiano di “ossificare la persona”, cioè ridurre i suoi comportamenti all’osso. Che i big data non devono essere considerati il nuovo petrolio, “perché sarebbe orribile immaginare che estraessero petrolio da noi, dalle nostre vene”. E che, in un mondo attraversato dalla trasformazione digitale, le aziende più lungimiranti devono essere consapevoli che l’innovazione “è una maratona, non una corsa di 100 metri”.
In questo scenario diventa sempre più indispensabile la “cultura del dato”. “Un tema focale – dice Floridi – che magari fino a poco tempo fa era presente essenzialmente nelle aziende che lavorano per altre aziende, le B2B, ma che va esteso al Business to Consumer. Qualsiasi azienda ormai deve avere una cultura del dato che vada a cogliere gli aspetti umano-centrici e customer-oriented”.
Professor Floridi, come si può costruire la cultura del dato?
Non solo comprendendo cosa significano i dati, ma anche ragionando su come utilizzarli al meglio con efficacia e innovazione. Questo include aspetti etici, oltre a quelli legali. È fondamentale che l’utilizzo dei dati da parte delle aziende sia a favore dei consumatori. L’imprenditore si deve chiedere: il mio uso dei dati è qualcosa che la mia clientela apprezza o si limita a sopportare?
Indice degli argomenti
DATI E AZIENDE: COME USARLI PER IL CLIENTE
Esempi concreti nel settore assicurativo o nel banking?
Immagino un’assicurazione che, in cambio dei dati, offra ai clienti un servizio di prevenzione gratuito oppure di supporto, per esempio quando si accorge che l’utente è bloccato con l’auto in mezzo alla campagna. Grazie alla disponibilità e alla gestione dei dati, la compagnia assicurativa sa che il cliente è fermo in quel punto, perciò lo può contattare in automatico e chiedergli se va tutto bene. Se poi quella compagnia ha un controllo sull’auto e si rende conto che sta funzionando male, potrebbe far arrivare sul posto il carroattrezzi. Il cliente gliene sarebbe infinitamente grato. Penso ai vantaggi dell’uso dei dati nel banking: per esempio una banca che non mi fa riempire i bollettini perché già conosce tutti i miei dati. È il mondo in cui ci piacerebbe vivere perché è in grado di rimuovere ostacoli e rendere la vita più facile. Ma proprio la strada verso la semplificazione è spesso mal intesa dalle aziende. Pensano che significhi dare empowerment al cliente. Invece il cliente non vuole essere empowered, vuole solo essere facilitato. Non gli importa di sapere cosa fa il suo ospedale o la scuola dove vanno i figli, ma di avere qualcuno che rimuova gli ostacoli in modo che lui possa darsi meno da fare. Perché fornire un’app per chiamare il carroattrezzi quando posso fare una telefonata? L’empowerment è stato usato a lungo dalle aziende sostanzialmente per liberarsi dalla responsabilità di gestire un processo.
“Le aziende devono assumersi la responsabilità di rendere più semplice la vita ai clienti”
In vari settori si sta pensando di arricchire la catena del valore dei dati tramite il processo di data enrichment che prevede nuovi tipi di big data, come quelli dell’Internet of Things, dei conti bancari e persino i dati genetici. Cosa ne pensa?
È un’idea intellettualmente stimolante ma, a mio parere, ancora molto teorica. Sarebbe interessante se il mio supermercato si coordinasse con il mio medico e insieme mi proponessero una dieta ad hoc in grado di farmi scoprire cibi che altrimenti non avrei acquistato. Ma ad oggi non funziona così. Viviamo in un mondo di silos, a scompartimenti stagni, molto frammentato: già far parlare il medico di famiglia con l’ospedale è un miracolo. I dati non si parlano tra loro e spesso scopriamo che, se si fossero parlati, le cose sarebbero andate diversamente. Penso a casi di terrorismo o criminalità comune, che avrebbero potuto essere prevenuti o arginati se i vari dati in possesso di polizia, carabinieri ecc. ecc. fossero stati condivisi. Tuttavia, se un giorno i processi di data enrichment diventassero pienamente operativi, i rischi sarebbero notevoli.
Perché?
Perché il data enrichment si avvicina sempre più al midollo dell’individuo e propone una sartorializzazione dei servizi e dei prodotti pensata per aderire a pelle sulla persona. In teoria è fattibile che, un domani, il supermercato possa dialogare con Amazon o con la palestra. Ma a quel punto l’individuo sarebbe completamente nudo davanti al data enrichment. I guai sarebbero enormi in termini di privacy perché si arriverebbe all’ossificazione, cioè si ossificherebbe l’individuo intorno a poche cose. Per esempio, se la domenica uno è solito bere vino bianco, grazie al data enrichment il supermercato lo sa e gli fa arrivare a casa, ogni domenica, quel tipo di vino. La grande distribuzione ne trae beneficio, l’individuo ne trae beneficio. Ma…se cambia gusto? Non siamo fatti per non cambiare: siamo malleabili, volubili, capricciosi. Il capriccio può voler dire essere aperti alle novità. Se a un certo punto del mio percorso cambio tragitto, questo significa che mi muovo in una realtà più aperta e libera. Il data enrichment è l’uomo che diventa profilo, è ingessare l’individuo in una casella. Certo, si fanno meno errori, ma gli errori – quelli reversibili – sono esperienze utili per imparare.
“Il data enrichment rischia di ingessare l’individuo in una casella”
Questi i pericoli. E i vantaggi?
Dipende da come viene interpretato e applicato questo arricchimento dei dati da parte delle aziende. L’utente sarà più soddisfatto e rilassato se sa che la sua banca comunica con l’assicurazione o con l’istituto con il quale ha stretto un mutuo. L’importante è che sia un mondo “al servizio di”, cioè che usi i dati per far star meglio il cliente, non che li sfrutti a proprio vantaggio. Si dice che i dati sono il nuovo petrolio, ma io non la penso così. È una pessima idea, per un’impresa, considerare i dati come un giacimento da cui estrarre petrolio, è come se estraessero petrolio dalle vene degli utenti, dalle nostre vene. Devono essere invece una risorsa messa a servizio dei clienti. Serve un’inversione di tendenza. Secondo me oggi il business non lo fa abbastanza ed è un’enorme opportunità mancata.
“I dati non sono il nuovo petrolio, non devono essere sfruttati solo a favore dell’impresa”
Cosa devono fare le aziende per mettere i dati al servizio del cliente?
Essere altruiste in maniera intelligente. Vincono quelle che hanno capito che la maggior parte del valore aggiunto è intangibile: know how, reputazione, forza lavoro. Ma questo non lo abbiamo spiegato bene ai giovani che hanno studiato economia. È stato detto loro che bisognava pensare in primis a tagliare i costi, invece l’azienda lungimirante deve investire sulle persone. L’aveva capito Olivetti e altri con lui. Oggi però ci sono aziende che non hanno interesse nel futuro. Preferiscono restare nel business per pochi anni, lavorano per i 100 metri, non per la maratona. A quelle bisogna fare un discorso legale, per esempio evitare, per legge, uno sfruttamento eccessivo del personale.
“La maggior parte del valore aggiunto delle aziende è intangibile”
BIG DATA E AZIENDE: COME USARLI PER I DIPENDENTI
A proposito di gestione del personale, nel welfare aziendale l’uso degli Analytics può aiutare a prevedere avvenimenti che si verificheranno nella vita dei dipendenti (l’arrivo di un figlio, la cura di un genitore anziano). Un’arma a doppio taglio per il lavoratore?
Il confine effettivamente è labile. Spesso si dice che la tecnologia di per sé è neutrale e che può essere usata in modo buono o cattivo. Non sono d’accordo: la tecnologia non è neutrale ma è a doppio valore. È come un coltello: non si può dire che taglia o non taglia a seconda di come viene usato, un coltello taglia sempre. Diciamo piuttosto che la tecnologia è un coltello bilama, ovvero ha doppia valenza. La richiesta che deve arrivare dal mondo del lavoro, e anche da quella parte di sindacato più collaborativo, deve essere: facciamo in modo che almeno questo coltello tagli da entrambe le parti. Cioè che la bivalenza della tecnologia sia o a favore della forza lavorativa, o anche a favore della forza lavorativa. Non può e non deve essere soltanto a favore della produzione dell’azienda.
“La tecnologia è un coltello bilama, non può essere soltanto a favore dell’impresa”
Come le aziende possono usare i big data in loro possesso a beneficio della forza lavorativa?
Immaginiamo che, in una fabbrica 4.0, i sensori realizzino che, nell’uso di alcuni macchinari da parte di un operaio, c’è qualcosa che non va. Nell’automotive già succede: l’auto connessa è in grado di percepire se la persona alla guida ha problemi di tipo cognitivo, cioè se sta guidando in modo diverso dal solito. Nel caso in cui, nella suddetta fabbrica, dal flusso dei dati emerga che l’operaio ha qualche problema, l’azienda dovrebbe usare questi dati per prevenzione, cura e supporto della persona, non per licenziarlo. Oppure immaginiamo che un altro dipendente faccia molte assenze. Con i big data oggi in possesso delle imprese, l’assenteismo è immediatamente identificabile. Il passo successivo dovrebbe essere quello di chiedersi perché la persona in questione sta facendo tante assenze e se l’impresa può darle una mano. È insomma necessario un utilizzo umano-centrico e altruista dei dati.
A qualcuno potrebbe sembrare una sorta di “buonismo” anti-economico.
Non lo è. L’azienda che rende migliore la vita alla propria forza lavoro ne conquista la good will e la fedeltà. E oggi avere una forza lavoro fedele è fondamentale. Le risorse umane sono preziose: hanno memoria storica, hanno seguito programmi di formazione, su di loro sono stati investiti tempo ed energie. CEO compresi. Un amministratore delegato che dura un paio di anni quale eredità può lasciare a un’impresa, se non l’onere di corrispondergli un generoso bonus di uscita? Magari si può riuscire a risparmiare qualcosa licenziando i dipendenti meno performanti, ma poi non si riesce a trattenere i migliori perché quello non è l’ambiente in cui vogliono lavorare. In UK abbiamo misure robuste per trattenere le persone più valide e molte aziende fanno a gara chi tratta meglio i dipendenti, in un contesto di competizione che è cosa buona, ovviamente all’interno delle regole sociali giuste. Così i dati possono diventare una strategia di business.