
Quando i grandi parlano, i meno grandi fanno bene a riflettere a lungo, prima di controbattere. Io credo di essere rimasto in silenzio, riflettendo, abbastanza a lungo prima di affrontare la recensione del libro di Joseph Stiglitz “The Euro and its threat to the future of Europe” (Allen Lane, Penguin Random House, 2016), che ho impostato nel mio primo pezzo dello scorso 22 settembre dal titolo Non è l’Euro a minacciare l’Ue, ma i governi dei paesi membri. Un titolo il quale annuncia già una presa di distanza sostanziale dalla posizione di Stiglitz, secondo cui la minaccia viene invece proprio dall’euro.
Oggi articolo ulteriormente la mia posizione passando a parlare della tesi di Stiglitz secondo cui uno stato membro dell’Uem, popolarmente nota come ‘area euro’, può liberarsi dai vincoli mortali imposti dalla moneta unica, da solo o alleandosi con paesi ‘simili’, ‘uscendo dall’euro’. La mia tesi è sinteticamente questa: sarebbe la fine del paese. Si noti che non parlo della fine dell’economia del paese, ma della fine del paese. Altri hanno affrontato il problema offrendo stime quantitative degli effetti potenziali della decisione; io mi asterrò dal fornirne, limitandomi a delineare gli scenari aperti dalla attuazione di una decisione di uscita. E siccome Stiglitz sembra pensare che tale uscita sia possibile anche per un solo paese, esempio ovvio la Grecia, parlerò di un solo paese che intenda uscire, e farò qualche riferimento al caso greco.
Il quesito da cui prendere le mosse è piuttosto ovvio: per quale ragione occorre ‘uscire dall’euro’? La letteratura anti-Ue sembra unanime nel sostenere che l’euro non è una ’area monetaria ottimale’. In subordine, o di conseguenza, un paese che si trovi a essere membro di una area monetaria NON ottimale si assoggetta alla disciplina di una moneta unica in maniera assimilabile a un paese che accetti di vivere in un regime di cambi irrevocabilmente fissi, e che dunque non potrà usare la leva della svalutazione competitiva per compensare le perdite di competitività internazionale dovute al differenziale negativo di produttività di cui soffre (più o meno endemicamente). In assenza di questa possibilità, si sragiona, occorrerà ricorrere alla deflazione salariale: vale a dire, alla precarizzazione del lavoro, alla riduzione dei salari a livelli inimmaginati fino a qualche anno fa, immaginabilissimi oggi. La logica? Abbassiamo i salari fino al punto in cui recuperiamo la competitività di prezzo che ci è negata dalla scarsa produttività. Chi propone di ‘uscire dall’euro’ vuole proprio evitare la ‘deflazione salariale’ e spostare il peso dell’aggiustamento sul cambio. Sembra complesso, ma non lo è. Due soluzioni ugualmente costose, ciascuna a suo modo.
Pensiamo dunque all’uscita la quale, chiaramente, viene percepita come una reazione alla deflazione salariale (leggi: condizioni di lavoro crescentemente indegne e salari crescentemente miserabili). Nobile, cercare una alternativa. Problema: qual è il costo dell’uscita rispetto al costo della deflazione salariale? Chi mi conosce sa bene, e chi non mi conosce dovrebbe aver capito dagli aggettivi che uso quando parlo di salari e di condizioni di lavoro, che trovo la ‘deflazione salariale’ odiosa e ingiusta. Ma mi debbo pur porre il problema in termini corretti, no? Vale a dire, qual è il costo dell’uscita? È un costo sopportabile? E soprattutto, è una strategia che possa veramente condurre alla terra promessa?
Due sono le linee di attacco alla tesi degli aspiranti fuoriusciti: una tesi puramente teorica, la quale sostiene che l’elasticità al prezzo in valuta estera delle merci di produzione nazionale NON fornirebbe quella ‘ripresa delle esportazioni’ che gli aspiranti immaginano. in altre parole, volete uscire per godere della libertà di svalutare, senza sapere che svalutare servirà prevalentemente a generare inflazione all’interno mentre scarso o nullo sarà l’effetto sullo stimolo alla produzione mediante l’aumento delle esportazioni nette. La seconda tesi è più articolata, come si diceva una volta, perché include la prima tesi, ma si appoggia su meccanismi più ricchi e complicati della semplice elasticità della domanda estera al prezzo in valuta estera: la chiamo ‘la tesi della fine del mondo.’
Tesi 1. Svalutare serve più a generare inflazione all’interno che a stimolare la domanda di esportazioni
Chi fa ricerca sui temi che stiamo discutendo sa bene, e se non lo sa dovrebbe studiare di più e meglio, che la nuova struttura dei processi produttivi e la loro localizzazione, in una parola quello che chiamiamo frammentazione internazionale della produzione hanno cambiato, e cambiano ogni giorno di più, l’impatto che una variazione del cambio può avere sulla competitività internazionale di prezzo. In estrema sintesi: quando una merce, o un servizio, viene prodotta in un solo paese senza il concorso di input prodotti all’estero, allora una svalutazione della moneta del paese in cui quella merce viene prodotta produce, sotto determinate condizioni e certamente non sempre, un effetto sul prezzo di quella merce in valuta estera. Ma si supponga ora di vivere nel XXI secolo, o anche nella quarta parte del XX, quando si è affermato un modo di produrre che smembra i processi produttivi, precedentemente integrati in un solo paese e magari in un solo impianto, in fasi che vengono allocate a imprese di paesi altri: certo, come amano pensare gli italiani, per ‘risparmiare sul costo del lavoro’; ma anche, come pensano invece altri, per andare a cercare risorse, competenze, capacità che siano utili all’aumento della produttività, della qualità, e nel frattempo anche a mettere un piede nel mercato in cui quelle risorse sono abbondanti. Quando il processo produttivo si conforma in questo modo, allora è facile vedere che una svalutazione della valuta nazionale rispetto al dollaro e/o sull’euro PUÒ stimolare competitività di prezzo dal lato delle esportazioni, ma CERTAMENTE peserà in maniera anti-competitiva sui costi di approvvigionamento all’estero di semilavorati, intermedi, e risorse in genere, compreso il costo del lavoro. Ergo, smettetela di sognare, se siete dei sognatori; e smettetela di cacciare balle, se queste cose le sapete ma le tenete nascoste per vostri interessi di parte.
Tesi 2. La fine del mondo
Supponiamo che il governo del paese che intende uscire tenga nascoste le proprie intenzioni fino a un momento preordinato; che abbia identificato l’unità di conto che intende proporre/imporre al popolo sottostante (non capisco chi parla di ‘tornare alla lira’, o alla dracma: lo fanno solo per amore del passato, ovviamente); che abbia organizzato la resurrezione della propria banca centrale come luogo di governo della politica monetaria; che abbia organizzato il sistema dei pagamenti interno, ecc. Cosa succede al momento dell’annuncio? Anzitutto occorre chiarire che il ‘tipo’ di uscita, cioè che sia un’uscita ‘amichevole’ o una separazione acrimoniosa, non fa differenza alcuna rispetto allo scenario che si prospetta, e ciò per una ragione molto semplice davvero: perché sono i mercati finanziari a decidere della piega che debbono prendere gli eventi, non i governi. Al momento dell’annuncio gestori di fondi comuni di investimento, capi di tesorerie, gestori di fondi pensione, banche e intermediari finanziari di tutto il mondo smetterebbero immediatamente di comperare debito del governo autore dell’annuncio e, per buona misura, richiamerebbero tutti i crediti erogati in valuta che, ormai, è valuta estera.
Il finanziamento della spesa pubblica ricadrà tutto sulle spalle dei residenti. I quali, non essendo fessi, e se sono italiani essendo particolarmente furbi, avranno comunque tenuto in forma liquidissima una quantità di euro che non useranno certo per finanziare il proprio governo. Nel frattempo, i debiti contratti in euro andranno ripagati in euro, perché nessuno accetterà carta straccia di nuovo (o vecchio) conio: non i governi, non le banche, non le imprese. I produttori di petrolio e di energia in genere, che non saranno furbi come gli italiani ma non sono neanche fessi, vorranno essere pagati in dollari Usa o euro. Che, come sempre, occorrerà procurarsi in uno di due modi: esportando più di quanto non si importi, o prendendo a prestito. E chi, dal resto del mondo, darebbe a prestito alle imprese, al governo, ai residenti di un paese che ha dichiarato che vuole svalutare? Nessuno. Per buona misura, chi controlla i canali di distribuzione delle merci e, in particolare, delle derrate alimentari, si guarderà bene dal metterle in circolazione in cambio di carta straccia di nuovo, o vecchio conio, e le famiglie cominceranno a far uso dei loro euro nascosti per alimentarsi approvvigionandosi sul mercato nero.
Ma mi rendo conto in questo momento che di questo meccanismo ho già scritto, e forse meglio di quanto non stia facendo ora, in un pezzo del 25 febbraio 2015, cioè quando andava di moda parlare di Grecia.
Conclusione? Non posso che reiterare la mia tesi: non è ‘restituendo’ ai singoli stati-nazione l’autorità sulla politica monetaria che il progetto di Unione europea progredisce, bensì trasferendo da loro all’Unione anche l’autorità sulla politica fiscale. Dando all’Europa quello che i governi nazionali hanno dato ai mercati. ‘Uscire dall’euro’ è sinonimo di ‘fine del mondo’.



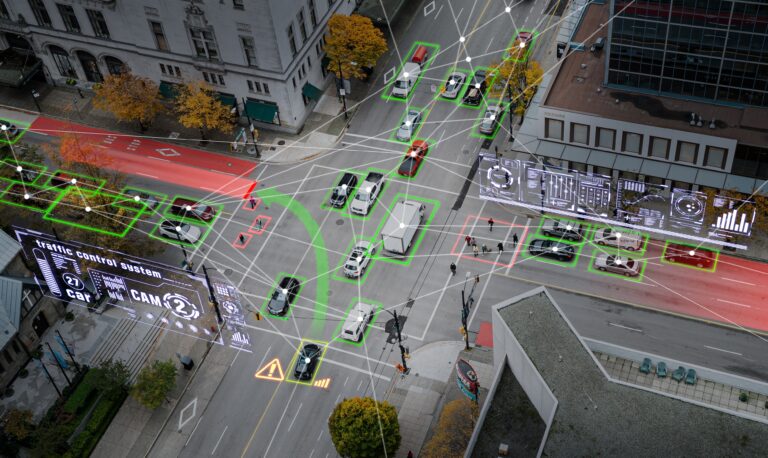

Due sono i fatti: o mi ha imbrogliato il prof. Papi, magnifico Rettore e titolare della Cattedra di Economia Politica dell’Università di Roma “La Sapienza” o mi vuole imbrogliare l’autore di questo articolo che non considera che le sue affermazioni sono soltanto la millesima parte di quanto lui non considera e che il prof. Papi ci insegnava sessantacinque anni fa.
Non sarebbe il caso che si rimettesse a studiare più seriamente?
Avv. A. S.
Ringraziandola per la ricchezza delle argomentazioni esposte, che trovo effettivamente interessanti, le chiederei di illustrare su quali dati o studi o ricerche si basino le sue interessanti opinioni. Sarei interessato a sapere insomma, su quale tavolozza attinge i colori con cui dipinge questo angosciante scenario da armageddon che nessuno, credo, vorrebbe vedere realizzarsi. Cosa ne pensa, ad esempio, di questa ricerca? http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2016-31.pdf Vorrei inoltre sapere come pensa sia possibile per gli stati europei, che attualmente sono nazionali, trasferire l’autorità politica e fiscale alla CE. Crede che la Germania sarebbe d’accordo? E la Francia? E se si in quali tempi? I tempi necessari saranno abbastanza brevi da garantire costi di permanenza in un’area monetaria, che anche lei ammette essere non ottimale, inferiori ai costi di uscita? Con quali modalità dovrebbero essere trasferiti questi poteri? Attraverso referendum (e se si scecomdo lei sarebbe possibile?) o imposti con la forza? È certo che sì attiverebbero quei meccanismi di trasferimento della forza lavorò, necessari al funzionamento ottimale dell’area monetaria? È certo che sarebbe possibile questo meccanismo in una comunità di stati dove si parlano lingue diverse, in alcuni casi si usano alfabeti diversi, convivono culture diversissime, e dove la lingua “più comune”, l’inglese, pare sarà eliminata dai documenti ufficiali, dato che la patria di tale lingua ha votato per uscire dalla UE. Ed a proposito di brexit: anche prima del referendum inglesesi sono usati toni molto tragici, mentre i dati attuali disegnano uno scenario abbastanza positivo, in cui la sterlina prima sopravvalutata (secondo il FMI), è tornata su valori tali da essere fisiologica più alla cosiddetta economia reale che alla finanza speculativa, che si trovava a proprio agio nella city? Finanza speculativa che peraltro è origine delle bolle che originano crisi mondiali (la Leman che lei cita nell’articolo, ad esempio). Sperando che abbia il tempo di rispondere, la ringrazio sentitamente.
si fonda?
Credo che abbia dimenticato, i fulmini e le saette che colpirebbero gli uccelli in volo creando quindi una catapultata di moribondi volatili sulla terra tanto da oscurare il sole.. abbia il coraggio di dire la verità.. l’euro è un metodo di governo fallito, una moneta che sta portando alla dissoluzione l’intera Europa. I popoli non accetteranno altri sacrifici per mantenere in vita l’eurone.
Mi stupisco che neanche lei parli degli effetti devastanti che una moneta nazionale, soggetta a continue svalutazioni (come la vecchia Lira), avrebbe su salari, pensioni e risparmio.
I salari e le pensioni perderebbero continuamente potere d’acquisto, con grande vantaggio dello stato che eroga pensioni e salari.
Stessa sorte toccherebbe ai risparmi dei privati cittadini, costantemente ridotti nel loro valore.