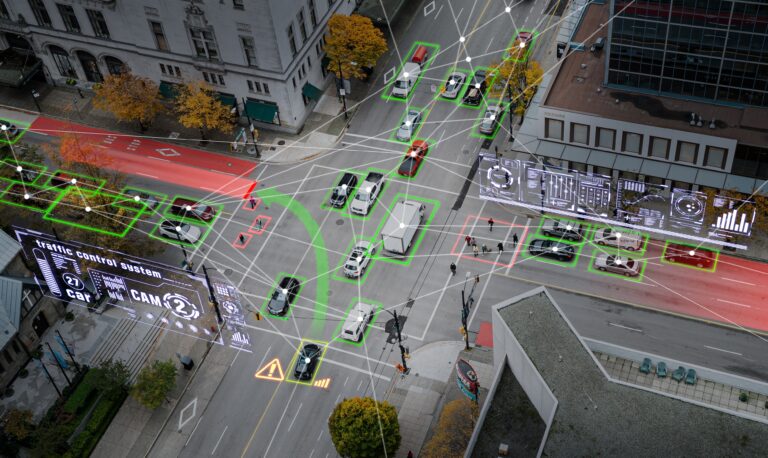Nel mio articolo del 16 febbraio scorso proponevo di pensare al fenomeno reshoring da un punto di vista puramente teorico, senza preoccuparmi della rilevanza quantitativa del fenomeno.
Il quesito era grosso modo questo: di quanto dovrebbe cadere il differenziale del costo del lavoro tra Paesi ad alto reddito pro capite e Paesi a basso reddito pro capite e, parallelamente, quale grado di avanzamento tecnologico sarebbe necessario perché il ciclo della globalizzazione che abbiamo chiamato offshoring si inverta? La risposta era: tanto, e tanto. Arrivavo alla conclusione, parziale e priva di fondamenti quantitativi, che per ora almeno di reindustrializzazione mediante rimpatrio non se ne parla, che i nazionalisti possono sognare il ritorno al passato quanto vogliono, e che il signor Trump, se dovesse puntarci, fallirà clamorosamente.
Ma, diranno gli amanti dei dati, e i dati dove sono? Ah, i famosi dati. Fortuna ha voluto che poche ore dopo la pubblicazione delle mie riflessioni su Economyup, il Sole 24 ore se ne uscisse con un suo pezzo, che offre una certa dose di evidenza empirica. Un pezzo importante. Leggendo il quale si può veramente imparare molto. E non solo in tema di backshoring.
Il titolo del pezzo del Sole: Addio delocalizzazioni? Gli Usa ripartono dal backshoring della manifattura.
Titolo in due parti, chiaramente, la prima che parla della fine della globalizzazione e la seconda del sorgere dei nazionalismi (produttivi, per carità). Bene. Cominciamo con Addio alle delocalizzazioni. Ma di quali delocalizzazioni si sta parlando? Non si tratta, per me, di un quesito da poco, perché ‘delocalizzazione’ è termine contro cui combatto da un quarto di secolo e non smetterò certo ora. De-localizzare vuol dire prendere da un loco e portare in un altro, o no? Chiedo: quante imprese conoscete, ciascuno di voi che avete la pazienza di leggere queste righe, che hanno ‘delocalizzato’? Dieci? Cento? Centinaia? Su quattro milioni e ottocentomila registrate in questo Paese!? Beh, l’ordine di grandezza dei fenomeni conta, no? Io non ne conosco che abbiano delocalizzato. Ne conosco migliaia e migliaia, invece, che hanno internazionalizzato la propria catena produttiva.
In Italia in prima linea nel reshoring, del maggio 2016, il Sole offriva una comparazione internazionale di interesse: le imprese interessate sarebbero 121 italiane, 326 americane, 68 nel Regno unito e 63 in Germania, complessivamente quasi (quasi?) 730 casi nel mondo. Dico: capisco che bisogna riempire i giornali e che tutti teniamo famiglia, ma sperare che io creda che questo sia l’Addio alle delocalizzazioni….
Ma torniamo all’obiettivo serio, che è di non confondere ‘delocalizzazione’ e ‘internazionalizzazione della catena delle forniture’. Brutta, la parola ‘delocalizzazione’. Confonde, non rappresenta minimamente la realtà della trasformazione delle catene di produzione da nazionali a globali; e poi lascia intendere che le imprese siano entità che godono di ampi gradi di libertà organizzative, gestionale, produttive, tecnologiche, così che con poco sforzo possono abbandonare fornitori provati e partners di anni, sostituire facilmente in produzione materiali di comprovata qualità, formare daccapo la forza lavoro, trovare le competenze … il tutto passando da un continente all’altro. Ma chi le imprese le conosce sa che così non è. Le imprese competitive sono quelle inserite in catene globali di produzione, fatto che consente loro di attingere alle migliori risorse, ai migliori sistemi scolastici, ai mercati di sbocco e di approvvigionamento più profittevoli, alle tecnologie nuove e, presumibilmente, migliori. Insomma, se parliamo di backshoring allora il suo contrario è l’offshoring, non una sognata ‘delocalizzazione’.
Il backshoring. E’ un fenomeno quantitativamente rilevante? L’articolo Addio… ci dice che “negli ultimi anni” (non sappiamo quanti, forse due o forse dieci, chi sa) ci sono stati ben “151 rientri di produzione”. Che cosa sarà un ‘rientro di produzione’? (Giuro, espressione mai sentita prima). Saranno 151 imprese che avevano ‘delocalizzato’ e che adesso hanno chiuso all’estero e riaperto negli Usa? Supponiamo sia vero che queste operazioni abbiano prodotto il mezzo milione di posti di lavoro di cui si parla nell’articolo. Bene, dico, felice per quel mezzo milione (e dispiaciuto per i sei milioni che nel frattempo hanno perso il lavoro). E questo è un numero che giustifica il titolo? Questo è il segno della grande inversione del processo di globalizzazione della produzione? 151 imprese!? Ma per piacere, è un numero risibile, statisticamente non significativo, indicativo di niente. Tale e quale quelli relativi ad altri Paesi e riportati sopra.
E veniamo infine alla politica del reshoring. Si narra che il nuovo presidente Usa abbia intenzione di incentivare il reshoring di quei posti di lavoro che le imprese Usa hanno ‘esportato’ negli ultimi quarant’anni e quindi, in ultima istanza, reindustrializzare l’America. Reshoring come una delle tante misure politiche protezionistiche, esempi delle quali potrebbero essere nuova legislazione che preveda che possedere residenza fiscale in Irlanda non sia sufficiente ad Apple per non pagare tasse significative al governo federale Usa (e neanche a quello irlandese, come abbiamo saputo qualche mese addietro); o, ancora, l’imposizione di dazi e prelievi importanti all’ingresso delle merci di produzione estera. Ma, manteniamoci lucidi: in che senso le importazioni Usa sono costituite da merci ‘di produzione estera’, se il processo produttivo è internazionalmente frammentato e le imprese ‘americane’ sono parte integrante di quel processo? Qualcuno ricorda un certo Tremonti che, anni e anni addietro, volle con forza dazi su importazioni da Cina e Vietnam, solo per sentirsi dire che non aveva capito niente, e che stava tassando prodotti di imprese italiane che stavano reimportando merce la cui produzione era stata avviata in Italia, poi esportate temporaneamente perché fossero sottoposte ad ulteriori processi di lavorazione all’estero, e poi reimportate nel territorio economico dell’UE? Insomma, alcuni nostri industriali gli spiegarono che con i dazi su tessile ‘cinese’ e calzature ‘vietnamite’ stava danneggiando il ‘made in Italy’!
A mò di conclusione
Le parole contano. Se le si vuole usare per ragioni di natura politico-ideologica, allora si è evidentemente liberi di usare quelle che si vuole, come si vuole. Se l’obiettivo, invece, è contribuire alla comprensione dei fenomeni e, perché no, contribuire alla identificazione di politiche economiche utili e rilevanti, allora bisogna fare attenzione. Altrimenti si corre il rischio di essere accusati di appartenere al mondo della post-verità e/o degli alternative facts.