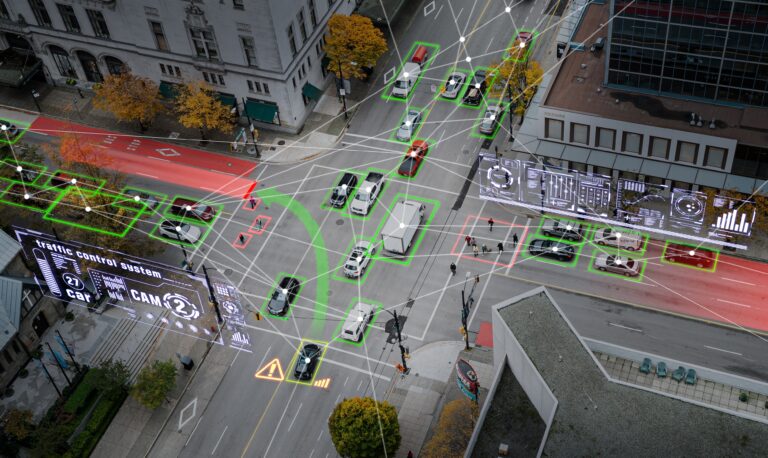Sono giorni di gran movimento per le scienze della vita. A partire da Milano, ovviamente, visto che Lombardia si può considerare la Biotech Valley italiana. Ottobre si è aperto con Meet in italy for life sciences, tre giorni di incontri, oltre 1500, tra aziende, centri di ricerca e investitori nazionali e internazionali. E fra pochi giorni sarà la volta della European Biotech Week, quando dal 12 al 18 per il terzo anno sarà celebrata in tutto il Vecchio Continente l’industria nata con la scoperta del DNA. L’Italia fa la sua parte, visto che è al primo posto per numero di imprese sul totale europeo (poco più di 73mila) e da questo settore ricava l’11% del Pil. Un settore in crescita, oltretutto, di circa il 4%, e con un’altissima capacità e intensità di innovazione: gli investimenti in ricerca e sviluppo ammontano a quasi 1,5 miliardi (con un incremento che va di pari passo con quello dei ricavi) e con una percentuale sul fatturato che arriva a superare il 30% nel nel caso delle aziende biotech pure.
Potrebbe essere un modello per tutto il sistema economico, se non fosse che il settore soffre delle stesse malattie sistemiche del Paese,
nanismo e sottocapitalizzazione prime fra tutte. Si notano immediatanebte scorrendo “Bio in Italy 2015″ il report del Centro Studi di Assobiotec, l’associazione di categoria che fa parte di Federchimica e quindi di Confindustria. Per questo ne abbiamo parlato con il presidente Alessandro Sidoli. «Siamo dietro Germania e Regno Unito», attacca. «Ma abbiamo ancora troppe aziende piccole e sottocapitalizzate». Bastano due numeri: il 62% sono micro e solo il 21% possono considerarsi medio-grandi. Se si guarda al pure bio-tech, la percentuale delle micro e piccole imprese sale al 93% e quella delle grandi all’1%. «Vanno bene startup, per carità. Ma non sono tutto, non possono essere tutto“, osserva Sidoli. «La nostra preoccupazione deve essere creare e sostenere vere aziende”.
“La nostra industria negli ultimi 30 anni si è sviluppata secondo una logica che prevede un’opportunità ed un investitore. Si sa che 90 progetti sono defstinati al fallimento e solo 10 ce la fanno, quando va bene”. Beh, proprio come succede per le startup…«Sì ma non mi stancherò mai di segnalare una differenza fondamentale: va bene considerare le startup un modello innovativo di impresa, però ci sono specificità nella nostra industria che fanno la differenza ed è una differenza galattica. Per esempio rispetto al digitale i tempi per portare un prodotto sul mercato sono lunghissimi, anche 10 anni; e poi servono molti più capitali”.
E per il momento sul mercato italiano non sembrano essercene ancora a sufficienza: sempre il Centro Studi Assobiotec fa notare che in Italia abbiamo solo l’1% degli investimenti di venture capital in Europa, rispetto al 42% della Gran Bretagna o al 15% della Francia. Differenza abissale. “Il fondo che opera nel settore con la maggiore dotazione di capitali è Principia con i suoi 150milioni, dietro non c’è molto”, ricorda Sidoli. “Forse il Fondo strategico italiano avrebbe potuto fare di più per un settore che fa sentire il suo impatto in modo pervasivivo in tutti i campi, dall’agricoltura alla salute…”. Qualcosa negli ultimi anni si è mosso, come spesso ha evidenziato Pierluigi Paracchi nei suoi interventi EconomyUp. E anche Sidoli riconosce che le condizioni per essere competitivi sono migliorate anche se non sono ottimali: “Abbiamo ottenuto il credito d’imposta sugli investimenti in ricerca, come succede in tutto il mondo, ma solo per cinque anni. Ma non c’è ancora un quadro normativo chiaro e favorevole per il settore. E poi resta sempre il costo della della burocrazia”. Anche per voi? “Le faccio solo un esempio: la difficoltà di assumere gli stranieri. SI rischia di diventare matti a star dietro all’equipollenza dei titoli di studio..”.
Nonostante tutto il biotech italiano negli ultimi due anni ha messo a segno alcuni colpo interessanti, da Eos a Silicon Biosystem. “Certo, abbiamo dimostrato di avere competenza, capacità di sviluppare prodotti validi e fare con questi un’impresa. Ma il success rate è molto basso e va bene solo se fai bingo. Eppoi quasi sempre si finisce per vendere a compagnie internazionali dopo aver lavorato di fatto in team molto piccoli. E invece sarebbe necessario che queste piccole squadre creassero vere e proprie aziende capaci di produrre ricadute positive sui territori. Questo ancora deve accadere”.
Il preisdente Sidoli quindi invita ad andare oltre le fortune dei fondatori di qualche startup biotech e guardare al sistema. “Il nostro è uno dei settori più innovativi, che potrebbe anche avere una funzione di traino. Il life science è il settore dell’open innovation per definizione, grazie al naturale connubio con il mondo della ricerca accademica, per esempio. “Per questo possiamo essere un modello per altri settori industriali”, conclude Sidoli, che offre un dato: “Se si va a vedere la pipeline di prodotti in sviluppo nelle big pharma, dal 30 al 70% dei prodotti sono stati acquisiti fuori dal perimetro aziendale, lì dove è stato ritenuto più elevato il tasso di innovazione. Non fanno mica tutti cosi…”. Neanche l’industria digitale.