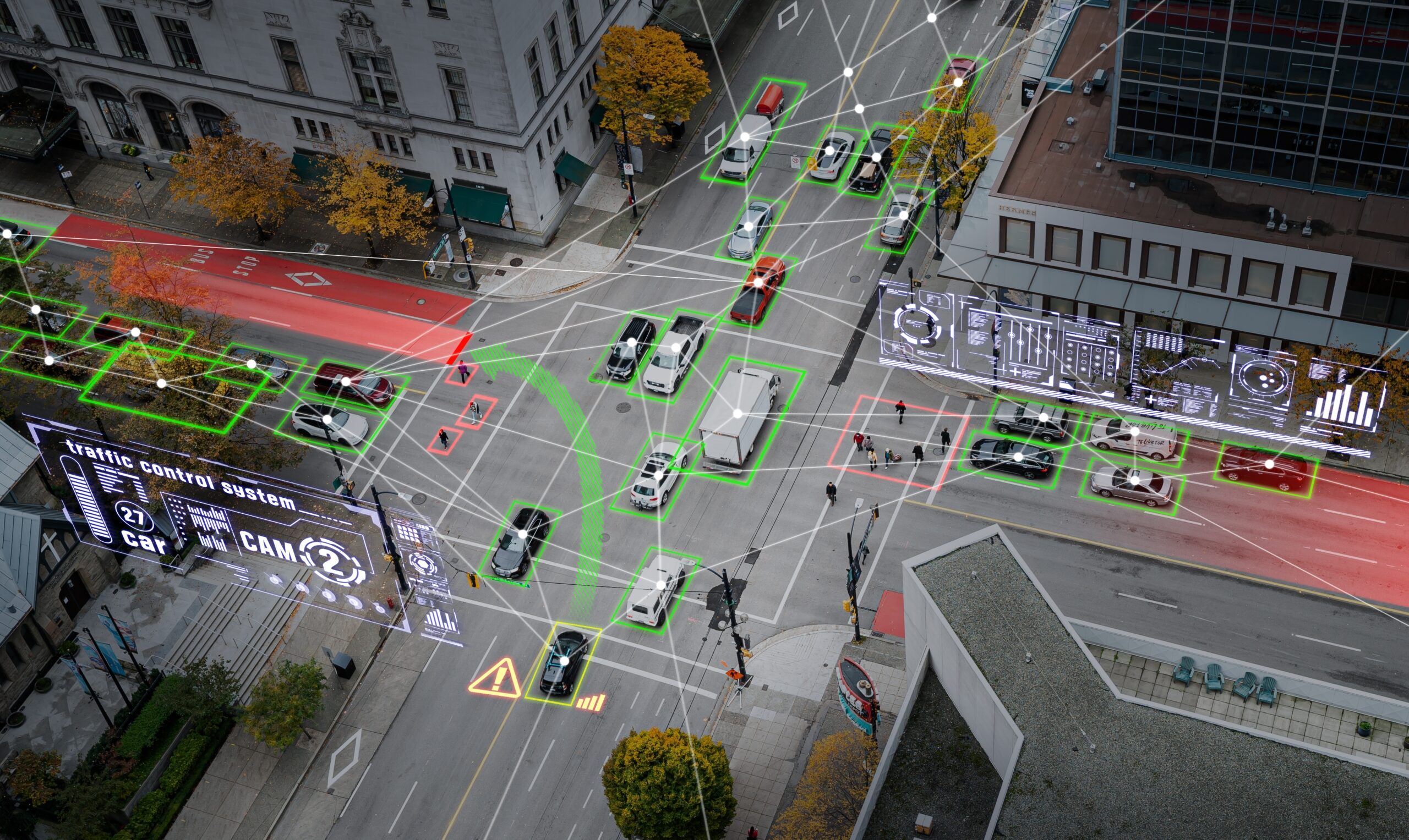La settimana scorsa abbiamo avuto notizia di una exit molto interessante, anche se non di una startup “canonica”. La catena di gelaterie Grom, fondata nel 2003 da Guido Martinetti e Federico Grom, è stata ceduta alla multinazionale Unilever. Si sono sprecati i commenti, più o meno divisi tra i complimenti ai due fondatori e il solito rammarico per il “made in Italy genuino che si svende alle multinazionali”. A questo coro di commenti, tra i quali raccomando quello di Giovanni Iozzia, comparso su questa stessa testata, provo ad aggiungere anche il mio, nel tentativo di lanciare una riflessione più generale sul “fare impresa” nel nostro Paese.
Inizio facendo i complimenti a Martinetti e a Grom. La loro storia imprenditoriale e il suo recente esito merita un plauso, a prescindere da quanto tutti noi possiamo ricamarvi sopra. Hanno avuto un’intuizione, hanno saputo cogliere l’opportunità, hanno saputo costruire (talora con tanta fatica) e hanno preso una decisione certamente non facile. Usare il loro caso per ragionarci su è – me ne rendo conto – un po’ strumentalizzare la loro storia. E di questo spero che mi perdoneranno. Ciò premesso, vedo nella storia di Grom tre spunti di riflessione che mi suscitano molte domande ma, lo ammetto, poche risposte.
Il primo ha a che fare con il prodotto. Grom è un’azienda esemplare nell’aver saputo coniugare tradizione e innovazione. Tradizione nel proporre il gelato “come una volta”, ma condita con parecchia innovazione. Un’innovazione che ha riguardato l’offerta (lo scegliere e il dichiarare esplicitamente ingredienti assai ricercati, oltre ai criteri usati per posizionare i negozi), e che ha investito anche la tecnologia utilizzata per assicurare il medesimo gusto in tutte le parti del mondo. Non a caso, proprio perché basata su una innovativa allocazione delle fasi produttive, l’impostazione industriale di Grom ha suscitato critiche nell’uso del termine “gelato artigiano”. Grom ci ha mostrato come l’Italia sia seduta su autentici tesori, se solo sapessimo coniugare tradizioni che ci vengono (per ora) universalmente riconosciute, con un po’ di innovazione. Mentre in Silicon Valley gli startupper si esercitano a creare variazioni su temi noti (“I’m building the Uber for X” “that’s cool, I’m working on the Airbnb for Y“), non sarebbe male se qualcuno in più dei nostri startupper lavorasse sul “Grom degli arancini” o sul “Tripadvisor del design”. Startup che richiederanno forse un po’ più di tempo a decollare, ma che potrebbero godere sin dal principio di un vantaggio competitivo importante, derivante dal territorio in cui nascono.
Quando però si passa dal prodotto vincente all’impresa, nascono i dubbi. C’è chi ha fatto paragoni tra Grom e Ben&Jerry’s, impresa per alcuni versi molto simile, nata nel 1978 e acquisita nel 2000 dalla stessa Unilever. Peccato però che Grom sia stata acquisita quando fatturava circa 30 milioni di Euro, mentre invece la gelateria del Vermont era quotata in borsa e fatturava 237 milioni di dollari. Ora, perché in Italia si riesce a costruire un ottimo prodotto, ma non a far crescere un’azienda? Perché Grom non è riuscita a “fare il salto”, e ha trovato nell’acquisizione da parte di Unilever l’unica vera chance per espandersi? E’ un limite del nostro sistema finanziario, per cui una IPO non era possibile, o i fondi di Private Equity non erano disponibili? E’ un limite dovuto a quell’intreccio tra tassazione elevata, leggi complesse e contraddittorie, e un sistema burocratico e giudiziario inefficiente, che tiene il nostro Paese ancora troppo in basso nelle classifiche internazionali della competitività? E’ un limite dovuto alla scarsità di manager che siano capaci di subentrare ai fondatori e far crescere le aziende al di là dei loro primi passi (ma, allora, perché non attirarli dall’estero)? O è un limite dovuto agli imprenditori, che non riescono ad avere una visione di ampio respiro? Sono domande ovviamente generali, che vanno al di là del caso Grom, ma alle quali dobbiamo poter dare una risposta se vogliamo avere una seria crescita economica, che veda in Italia non solo centri di costo, ma anche centri di profitto.
E qui nasce l’ultima considerazione, nella quale si passa dalla singola impresa a una prospettiva più ampia. E’ una considerazione ancora acerba, dinanzi alla quale non riesco a darmi non dico risposte, ma nemmeno a formulare delle ipotesi. Perché, in un settore come quello del food and beverage, settore nel quale l’Italia ha un ovvio vantaggio competitivo, non esistono multinazionali italiane capaci di assorbire e federare i marchi del made in Italy per proporli sui mercati mondiali (ma lo stesso ragionamento si potrebbe fare per il settore del lusso)? Perché le uniche grandi imprese italiane del settore, come Ferrero, Barilla e Lavazza sono essenzialmente degli specialisti monoprodotto? E qual è il futuro del made in Italy e della relativa creazione di valore, se l’unica chance per affrontare con una scala sufficiente i canali distributivi globali, o per affrontare i passaggi generazionali, sta nel confluire in un grande gruppo straniero?
Pertanto, mentre facciamo i complimenti a Guido Martinetti e Federico Grom, possiamo sperare che imprenditori e manager italiani riescano in tempi non lunghissimi a costruire una nuova Ferrero e, perché no, una nuova Unilever.