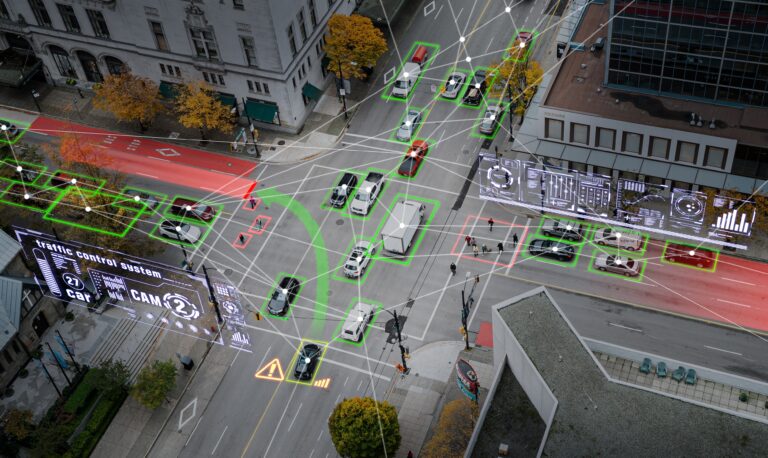A un mese dal debutto Banzai, prima matricola 2015 nel listino principale, viaggia ancora abbondantemente sotto il prezzo di collocamento (5,895 contro 6,75). Esattamente un mese dopo, il 16 marzo, arriva in Borsa Digitouch, compagnia di digital marketing che è la sessantasima società nell’AIM, il segmento dedicato alle piccole e medie imprese. Un’area dove forse l’impatto con il mercato è più mediato, visto che non è sempre morbido per le compagnie digitali. Nell’autunno 2014 ItaliaOnLine invece aveva rinunciato al collocamento all’ultimo momento. È la Borsa che non ama e non comprende le nuove società digitali o sono le imprese digitali a non avere numeri e prospettive convincenti per la Borsa? Ne abbiamo parlato con Umberto Bertelè, docente di Strategia al Politecnico di Milano, Chairman degli Osservatori Digital Innovation e autore del libro Strategia (Egea). Bertelè il 24 marzo terrà una lectio magistralis sulla Disruptive Innovation al Politecnico di Milano (è possibile registrarsi qui)
Professore, la Borsa italiana non ama il digitale o il digitale italiano non è pronto per la Borsa?
«Provo ad abbozzare qualche risposta. In primo luogo abbiamo una Borsa debole, ancora lontana dai livelli ante-crisi (a differenza ad esempio del Nasdaq che il 2 marzo è ritornato addirittura ai valori antecedenti lo scoppio della bolla Internet), sempre affollata di banche e anche per questo con gli occhi sempre rivolti alla BCE, poco sensibile – come fino a poco tempo fa gli italiani in genere – alle startup e alle nuove tecnologie, forse ancora memore delle perdite quasi totali provocate dall’entusiasmo per le dot.com ai tempi della bolla Internet. L’IPO non è facile per nessuna impresa, gli umori del mercato sono molto variabili e il rinvio della quotazione “in attesa di tempi migliori” è all’ordine del giorno per tutti, a prescindere dal comparto.
Quindi Banzai sta patendo questo contesto generale?
Per quanto concerne in particolare Banzai, che ha ora una capitalizzazione di circa 237 milioni di euro, è presto per dire a cosa sia dovuto e se sia destinato o meno a confermarsi il calo rispetto all’IPO. I valori sono spesso “pompati” in sede di collocamento e può capitare anche a grandi imprese di vedere calare il valore del titolo nei mesi successivi: Facebook dimezzò ad esempio il suo valore di 100 miliardi di dollari nel periodo successivo alla quotazione, ma riuscì poi con i suoi risultati a convincere il mercato di non essere solo un bluff, sino a portarsi agli oltre 200 miliardi attuali. In sintesi, non credo che si possa attribuire con certezza quanto capitato a ItaliaOnLine e a Banzai alla loro natura digitale. Anche se il tema del sentimento della Borsa nei riguardi delle startup digitali che vogliono crescere mi sembra di grande importanza, in una fase storica in cui la speranza del nostro Paese di riprendere ritmo è in larghissima misura legata alla nascita di nuove imprese e in cui è difficile immaginare nuove imprese di successo che non abbiano almeno “un po’ di digitale” nel loro business model.
Quali sono ancora i limiti delle compagnie tecnologiche e/o digitali italiane?
Non sono un conoscitore così profondo delle realtà emergenti nel nostro Paese da potermi permettere un giudizio assoluto. Quello che mi colpisce però è che molte delle startup sembrano più replicare per il mercato italiano business model messi a punto altrove, che non proporre business model innovativi per il mercato mondiale: una scelta per certi versi comprensibile, ma che può condannare a operare in una logica di nicchia; una scelta fortemente vincolante per il futuro, perché l’uscire dalla nicchia vorrebbe dire combattere in un oceano rosso (riprendendo una celebre definizione) contro i grandi che operano a livello mondiale. Non sempre è così, e voglio fare – senza nessuna pretesa di completezza – due esempi. Ho sempre ammirato Yoox, impresa nata agli inizi del secolo che ha saputo coniugare l’ecommerce con una “specialità” italiana come la moda, proponendosi come operatore su scala mondiale. Yoox, anche se trattata in modo non molto clemente dalla Borsa negli ultimi tempi, vale 1,2 miliardi di euro: un valore basso rispetto alle tech company statunitensi, ma tutt’altro che trascurabile per la Borsa italiana. L’altra società che merita citazione, fatta da italiani ma da essi locata a Chiasso e quotata a Zurigo, è Bravofly Rumbo (240 milioni di franchi svizzeri di capitalizzazione, con una caduta rispetto all’IPO per i risultati inferiori alle attese), nota in Italia per il suo motore di ricerca per voli e vacanze Volagratis. I suoi punti di merito, in un mercato che vede la presenza di operatori come Expedia o (per la sola componente alberghiera) Booking: aver cercato di differenziarsi puntando l’attenzione sulle low-cost e avere guardato all’Europa – anche attraverso acquisizioni – come mercato di riferimento.
L’accoglienza in Borsa e l’andamento successivo sono ancora segnali validi dello stato di salute di una società e delle sue possibilità di crescita?
La Borsa dovrebbe essere il logico punto di arrivo di una impresa sana e con voglia di crescere, il punto di approdo dopo un percorso in cui i business angel e il venture capital (e di recente anche il crowdfunding) hanno contemporaneamente i ruoli di valutare la bontà delle idee, di fornire consigli su come trasformare un’idea in un’impresa e di fornire le risorse finanziarie indispensabili per attuare questa trasformazione: in gara con l’altra opzione, quella di vendersi a un’impresa più grande (come ha fatto clamorosamente ad esempio WhatsApp accettando i 19 miliardi di dollari offerti da Facebook). La grande novità di questi ultimi anni è la tendenza di molte startup di successo di rimandare la quotazione in Borsa e di avvalersi di finanziamenti privati per crescere prima dell’IPO.

Quanto contano i canali alternativi di finanziamento alternativi alla Borsa?
Sempre di più. Pochi mesi fa ad esempio la cinese Alibaba è giunta con finanziamenti privati a una consistenza tale da raccogliere con la quotazione al Nyse 25 miliardi di dollari (la più alta cifra della storia), con una capitalizzazione superiore a 200 miliardi. Il fenomeno si è così diffuso che The Wall Street Journal [ha virtualmente creato The Billion Dollar Startup Club, il club delle imprese non ancora quotate che hanno superato la capitalizzazione implicita (calcolata sulla base dei prezzi pagati dagli ultimi finanziatori) di 1 miliardo di dollari. Il club comprende ben 75 imprese, le prime 8 delle quali con un valore di almeno 10 miliardi. In testa Xiaomi, leader negli smartphone sul mercato cinese e con soli 4 anni di vita, che vale 46 miliardi e ne ha raccolti 1,4, seguita da Uber, che vale 41,2 miliardi ma ne ha raccolti il doppio.
Questi valori verrebbero confermati se un componente del club decidesse di andare in Borsa?
Non sempre la capitalizzazione implicita trova conferma in sede di IPO, anche perché è facile immaginare che si possa fare un uso strumentale degli ultimi finanziamenti, per gonfiare i numeri agli occhi dei possibili sottoscrittori. Sono molti gli esperti convinti che si tratti di valori mediamente eccessivi, spiegabili con l’abbondanza del cash in cerca di investimenti e con il livello straordinariamente basso dei tassi di interesse. È altrettanto diffusa però la convinzione che la situazione sia molto diversa rispetto a 15 anni fa, quando la bolla Internet scoppiò, perché sono molte le imprese del club che hanno ricavi significativi e in salita e che in qualche caso sono addirittura in utile.
Professore, quali conclusioni si possono trarre?
Dobbiamo, come italiani, darci da fare. Dobbiamo mettere in pista più strutture di ausilio allo sviluppo delle startup, ma anche cercare di “pensare in grande” e di guardare al mondo come mercato.